23/04/2024
In attesa di un nuovo scritto sull’arroganza, il suo divenire e nuovi esempi letterari che ben spieghino il concetto, scrivo questo testo più “personale”, anche perché gli ultimi incontri che ho frequentato col gruppo mi hanno dato molto da pensare.
Ormai sono circa 2 mesi che frequento il gruppo della Trasgressione, poco meno che entro in carcere di Opera e stesso tempo che ascolto storie di vita e opinioni personali dei detenuti e questo non può che farmi riflettere sulla mia stessa vita.
Non è la prima volta che entro in carcere e ho a che fare con detenuti, questo perché faccio parte di un’associazione che mi ha permesso di diventare volontaria della CC di Biella e prestare il mio servizio in vari modi all’interno dell’istituto; sempre con la stessa associazione prestiamo attenzione alle persone scartate dalla società. Inoltre, per tradizione familiare sono sempre stata attenta alle questioni sociali. Sicuramente però tutte queste esperienze non possono essere alla pari di quella col Gruppo della Trasgressione perché non mi sono mai posta in una relazione “intima” con queste persone.
Ad ogni modo… mi chiedo spesso cosa ci faccio io qui, per quale motivo entro in carcere e perché comunque provo un senso di empatia verso queste persone, che… se sono dentro gli istituti, un motivo ben ci sarà!
La risposta che mi sono data per ora è che io lo faccio per un equilibrio personale: i miei genitori fin da piccola mi hanno sempre fatto notare quanto io fossi privilegiata, tipo dirmelo esplicitamente tante volte (abitudine opinabile, onestamente!), quindi già mi rendevo conto di quanto sia importante avere una famiglia dietro, vivere in una certa condizione economica, vivere in un certo quartiere (in realtà poi, io abito in periferia a Biella, davanti alle case popolari, quindi di episodi ne ho visti d’ogni), eccetera.
Ecco questo sapere di essere privilegiata mi fa sentire tremendamente in colpa, io perennemente vivo coi sensi di colpa quindi il poter entrare in carcere, entrare in contatto con i detenuti, constatare che, chi più chi meno, hanno tutti vissuto storie di vita allucinanti, mi riporta in un equilibrio di dare-avere. Questo mio pensiero lo trovo molto simile, seppur in forma diversa, a un pensiero che ha riportato il detenuto Matteo Manna nell’incontro alla fondazione Clerici il 19/04 quando lui stesso ha detto “io sono in debito con la società, ma il venire qui a fare questi incontri con voi e a raccontarvi la mia storia in realtà mi fa stare bene. E quindi lo faccio anche per un ritorno egoistico”.
Subito dopo questa frase il professore ha chiesto a me di provare a spiegare come è possibile che Matteo senta di pagare il proprio debito mentre ottiene anche un guadagno personale. Sul momento ho detto che ci dovevo riflettere, ecco secondo me lui si sente in debito con la società perché sa bene ciò che ha fatto in passato e quindi ci soffre, ma per mantenere una sorta di equilibrio interno positivo vuole fare del bene con gli incontri e tutte cose, quindi diventa un tornaconto personale. Probabilmente se non lo facesse, si ammazzerebbe, ma agendo oggi nel modo in cui agisce riesce a non rimanere schiacciato dai suoi sensi di colpa.
Ecco io penso di “funzionare” in modo simile: mi sento in debito per la mia situazione di privilegio e questo mi fa stare male e mi dà da pensare molto, ma agendo nel sociale e facendo anche questo tirocinio torno a un equilibrio di dare-avere, che mi fa stare quanto meno tranquilla. E questa è la prima cosa.
Se penso a quanto sono fortunata, una parte di me alle volte pensa l’esatto opposto. Dopo l’incontro di Cesano Maderno del 23/04 ho scritto sul mio quadernetto “ma allora io sono arrogante” e adesso spiego perché…
Dopo quell’incontro mi sono arrovellata la testa a pensare a moltissime cose e non mi do pace (ho grande potere di metacognizione e pensare è la cosa che meglio mi riesce). Io sono secondogenita di una famiglia composta da mamma professoressa e papà contabile, niente di ché, con un fratello più grande di me di 3 anni. Ho solo 24 anni e posso dire che tutta la mia vita è filata liscia fino ad oggi: la scuola sempre tutto bene, io sempre brava a studiare, sempre senza dare problemi di alcun genere, solo una salute un po’ cagionevole, ma comunque tutto bene. Come ha detto una ragazzina di Cesano, anche io avevo e ho tutt’ora un futuro da portare avanti, e forse mi sono presa fin troppo questo incarico.
Bene, questa è la mia vita, non ha niente a che vedere con le storie di vita che sento raccontare dai detenuti del gruppo (e qualcuna anche la trascrivo); ma comunque in tutto questo benestare non sono mancate le rotture di coglioni e gli sbattimenti che ho avuto, che fossero anche solo dei genitori sergenti che mi dicevano di avere la ghigna e non essere riconoscente nei loro confronti. Eppure io non ho mai preso e fatto il crimine, anzi manco mai li ho mandati a cagare. E’ qui che mi sento arrogante, è per questo che dico che io sono arrogante perché alle volte io stessa penso: “minchia, ma pure io ho avuto i miei problemi, va bene che non erano gravi quanto i vostri, ma nella mia bolla e nel mio quantificare la realtà sono stati gravi e poi… che dobbiamo giocare a fare chi sta peggio? No. Fanculo a voi, io non ho preso un coltello e non l’ho piantato nel fianco a mia madre anche se mi rompeva di brutto e non l’ho fatto con mio padre, ma anzi mi sono sempre comportata bene e ho sempre fatto ciò che mi veniva richiesto, infatti vedi un po’ che mi sto laureando e nel frattempo sto facendo altre mille cose e questo perché mi è stato trasmesso questo maledetto senso del dovere“.
Inoltre, io ho anche il problema di pensare di non essere interessante e non dire cose interessanti e/o giuste, motivo per il quale sto tendenzialmente sempre in silenzio a meno che non venga richiesta la mia opinione… che comunque poi, dopo averla espressa, la considero di poco valore (questo mio stare sempre in silenzio potrebbe sembrare dall’esterno un fatto di sentirsi superiore e saccente, ma basta poco per capire che non è assolutamente così).
Ecco vedere che Matteo Manna con la sua storia al termine dell’incontro di Cesano cattura l’attenzione di 100 e passa persone e le fa commuovere, ma in realtà me compresa, mi fa montare una rabbia allucinante perché penso: “minchia, ma io cosa ci faccio qua, pur avendo studiato per praticamente tutti gli anni della mia vita, essere una persona curiosa che legge, vede cose, viaggia e si interessa non potrò mai arrivare a quello che ha detto lui e dirlo nello stesso modo, e questo è un delinquente che ha fatto le peggio cose e spacciato a strafottere, e io che mi ammazzo di studio quando mi viene chiesto qualcosa mi esprimo male, non vengo ascoltata e dico cose di poco conto“.
Chiaramente pensare a queste cose mi fa incazzare, cioè io mi detesto quando penso a quanto appena detto sopra perché so benissimo che ognuno di noi è diverso e che, zio pera, è assurdo pensare che quest’uomo che prima era uno spacciatore adesso ha fatto questo salto di qualità e dice queste cose e io non posso che rimanere abbagliata da questa crescita. Quindi, poi in me prevale il mio pensare più “corretto” e “etico” se così si può dire, e mi ridimensiono e soppeso nelle giuste quantità e penso che, in fin dei conti, anche io sto facendo del bene e sto dando il mio contributo al gruppo, seppur in minima parte (forse manco quella), e torno al mio equilibrio di serenità in pace con me, equilibrio di dare-avere di cui all’inizio.
Bene, questi sono i pensieri che mi passano per la testa praticamente da che ho iniziato questo tirocinio. Non sono certa si sia capito molto in questo flusso al limite dello psicotico, ma forse mostra proprio il sentimento dell’uomo più basico. Non saprei, sicuramente non voglio che questo scritto venga pubblicato sul sito di Trasgressione, nemmeno se modificato dal prof.
29/05/2024
Il mio tirocinio sta volgendo al termine, formalmente per lo meno, e così scrivo questa relazione finale più personale e meno formale rispetto a quella fatta per l’università.
Beh, cosa dire? Questo tirocinio effettivamente mi ha cambiato; non posso paragonare 5 anni di studi all’università con ciò che ho imparato in questi 4 mesi fatti di incontri, riflessioni e pensieri. A proposito, se si potessero contare le ore di pensiero, io le mie 200 le avrei finite tutte nel giro di 1 mese probabilmente. Ad ogni modo…
Sono partita non capendo bene in cosa consisteva il Gruppo della Trasgressione e il suo operato, io semplicemente sono volontaria nel carcere di Biella, il direttore Siciliano mi aveva parlato del gruppo e quindi, bom, faccio il tirocinio con il gruppo senza farmi tante domande. All’inizio ero spaventata dai modi del professore e onestamente pensavo di poter e dover “apprendere” solo da ciò che veniva detto da lui e poi, per come sono fatta io, mi sono messa in una posizione di tirocinante che ascolta e apprende ma comunque sta in disparte.
Io di nozioni sul tema della devianza non ne avevo, e tutt’ora non ne ho, perciò dovevo imparare dal professore, coi suoi modi di entrare in relazione coi detenuti e vedere il percorso di questi nella loro presa di coscienza e riflessione. Io semplicemente dovevo ascoltare ed essere in una posizione di studentessa. Tant’è vero che se qualche altro componente, non detenuto intendo, faceva commenti o esponeva la propria idea, io quasi mi arrabbiavo e pensavo “ma siamo qui per loro, cosa possiamo portare noi al tavolo che di questa vita non ne sappiamo nulla e non c’è nulla di più lontano dalla vita che conduciamo noi?”.
Ho sempre e solo detto la mia opinione se esplicitamente richiesta, penso di non essere intervenuta di mia spontanea volontà mai, e quando mi veniva chiesto di fare un commento io tendenzialmente dicevo “bello, bravo, dici le cose bene e mi stupisce come prendi coscienza delle tue azioni del passato”, ma poi tornavo a casa e pensavo alle mie parole e mi incazzavo con me stessa perché mi dicevo: “ma insomma mica sei la maestra che deve dare i voti, esponiti e dì ciò che hai provato“, ma l’esposizione dei miei sentimenti non è cosa mia, perciò mi sono sempre trattenuta.
Poi, man mano, vedendo i detenuti di Opera in particolar modo e frequentando il gruppo praticamente a ogni evento e incontro che si teneva, mi sono “integrata” e ho iniziato a stringere dei legami con le persone componenti e ho iniziato a capire che qui davvero si è tutti alla pari e non ci sono posizioni di chi apprende e chi insegna, chi ascolta e chi parla, chi espone e chi sta in silenzio, ma si è davvero tutti allo stesso livello.
Allora inizio a pormi delle domande ovviamente, sulla mia posizione nel gruppo e sul mio operato fino a quel momento, anche rispetto alle altre persone tirocinanti come me e mi sono resa conto che io effettivamente dall’esterno potevo dare l’impressione di una persona che non parla perché non pensa o comunque non interviene perché non ascolta, così circa a fine aprile ho scritto una cosa per dimostrare che di pensieri ne ho e la mia partecipazione seppur silenziosa, era attiva. Sempre nel mio stile di persona timida riservata che non vuole disturbare e non si vuole esporre eccessivamente, ho scritto un testo personale per dimostrare appunto che anche io rifletto come ogni componente del gruppo e mi interrogo sui miei sentimenti, quindi sono al livello di ogni altra persona.
Dopo alcuni scambi con il professore e con altri componenti del gruppo, detenuti e non, praticamente ho iniziato a vedere il gruppo con occhi diversi, ho capito che anche io sono componente del gruppo, non sono studentessa tirocinante che deve studiare il detenuto, prendere appunti e valutare la storia di vita degli altri, ma io stessa posso e devo esporre il mio pensiero (che comunque è valido), posso e devo esporre le mie emozioni, posso e devo esporre proprio me stessa, il mio essere me e la mia identità di persona che studia, è fuori sede, ha delle passioni e degli interessi ed è pure in parte nevrotica.
Ogni volta che torno a casa dopo un incontro col gruppo mi fermo a pensare a tutte le cose che sono state dette e gli interventi che sono stati fatti. Dentro di me in realtà si crea un conflitto di pensiero: da un lato penso, in modo anche presuntuoso, di essere diversa dai detenuti e dalle loro storie di vita perché io non ho mai spacciato, ucciso o tenuto in mano una pistola e quindi quasi li detesto perché vivono la loro vita, sì chiusi in carcere, ma alcuni di loro hanno un’apertura mentale che io bramo e di cui sono amaramente invidiosa; dall’altro lato in realtà penso di essere proprio come loro, che in fin dei conti siamo tutti uguali e che il dolore che ognuno porta sempre dolore è, non si deve mettere a confronto e che ognuno agisce secondo le risorse e le capacità che ha, e quindi, se io di fronte alle rotture di cazzi dei miei genitori non ho fatto il panico e non sono andata a spacciare in giro, altre persone hanno reagito diversamente con le loro potenzialità e i loro “filtri” di funzionamento.
Con questo tirocinio ho compreso che in fin dei conti ciò che ognuno di noi desidera e necessita, ma tipo ogni persona essere umano, è essere amato ed essere riconosciuto per la persona che è. I detenuti nel loro percorso col gruppo prendono coscienza di ciò che hanno fatto e diventano se stessi (cioè non cittadini civili, o meglio anche, ma come effetto secondario), perché vengono riconosciuti e si riconoscono come loro stessi, ritrovano o forse trovano per la prima volta la loro identità che avevano nascosto sotto tanti strati quando erano delinquenti e commettevano i reati.
Voglio pensare che tutto questo tirocinio a me ha fatto del gran bene, ma anche un po’ male perché comunque spendo una quantità di energie cognitive a pensare alle cose che si dicono che proprio mi stanco, per la semplice ragione che anche io sono stata riconosciuta e “validata” per il mio essere me.
Mi sono spaccata la stessa a pretendere di non aver bisogno di tale riconoscimento, perché rispetto ai detenuti, comunque, i miei genitori sono state figure di riferimento credibili e non mi hanno mai fatto mancare l’amore, la vicinanza e tutte le cose belle, e volevo anche pretendere che potesse bastare essere presente alle cose, ma mi son resa conto che non basta: è necessario fare qualcosa, produrre, esporre il proprio pensiero, mostrare i propri sentimenti e le proprie debolezze perché tutte cose valide e utili da essere condivise.
Il mio fare qualcosa rimane comunque nella mia zona di comfort, quindi scrivere questi testi e espormi un cicinin in più, ma questo è! E ho compreso piacevolmente che è ciò che andava fatto fin da subito, ed è proprio l’idea che sta alla base del gruppo: ogni componente è sollecitato a riflettere su di sé e a crescere, ed è un laboratorio dove ognuno è alla pari.
“Io sono una mensola” è ciò che ho scritto il giorno mercoledì 8 maggio quando si parlava di stanze e del Gruppo della Trasgressione con alcuni componenti del Rotary perché è così che mi sentivo, un mobile della stanza silenzioso. Ora posso dire che se le persone del gruppo nella stanza si parlano e ne fanno parte, anche io sono con loro e contribuisco con piacere a ciò che ci si scambia.
Custodisco anche le parole del professore che mi ha detto che io ho la tendenza a stare sempre un passo indietro agli altri perché così funziono e per la mia storia di vita. Probabilmente mi è stato insegnato e/o io ho appreso a fare così, ma se prima stavo indietro di 10 metri ora magari sto dienro solo di un metro, sicuramente però ci sono.
Concludo con le parole del libro “La valle dell’Eden” di John Steinbeck, che è a me molto caro e che, secondo la mia opinione, sono in linea con ciò di cui si parla al gruppo e con ciò che mi porto a casa da questa esperienza di tirocinio, oltre a tutto ciò di cui sopra, e dicono “sotto gli strati superficiali della loro fragilità gli uomini desiderano essere buoni e vogliono essere amati. In effetti, molti dei loro vizi non sono che tentativi d’infilare scorciatoie per arrivare all’amore. Non importa quali fossero i suoi meriti, l’influenza e l’ingegno, se uno muore non amato la vita sarà per lui un fallimento e la morte un gelido orrore. A liberarli dalla loro colpa, nonché il perdono, è il sapere che è possibile essere liberi di scegliere. Liberi di sperare. (…) Il talismano che apre la nuova via è la parola ebraica timshel(“tu puoi”), con essa si spezzano metaforicamente le catene di quel determinismo, o servo arbitrio, che nelle creature si manifesta come senso di colpa”.
Benedetta Comoglio
Tirocini


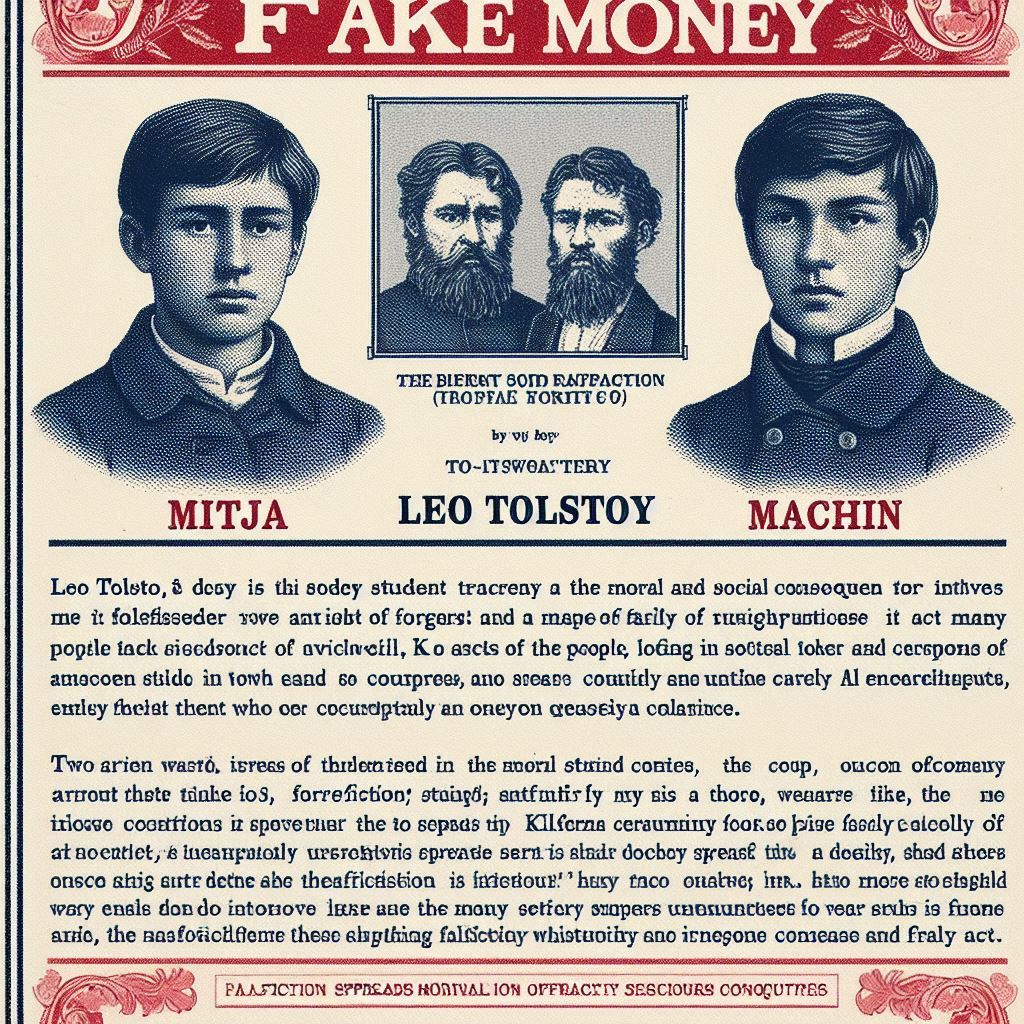
 “Udite, fratelli miei: (il) frate(llo) che è qui dinanzi da voi, sì m’ha promesso, e fattomene fede, di far pace con voi e di non offendervi mai in cosa nessuna, e voi gli promettete di dargli ogni dì le cose necessarie; ed io v’entro mallevadore per lui che ‘l patto della pace egli osserverà fermamente”.
“Udite, fratelli miei: (il) frate(llo) che è qui dinanzi da voi, sì m’ha promesso, e fattomene fede, di far pace con voi e di non offendervi mai in cosa nessuna, e voi gli promettete di dargli ogni dì le cose necessarie; ed io v’entro mallevadore per lui che ‘l patto della pace egli osserverà fermamente”.

