Carla Chiappini intervista Angelo Aparo
Aparo: sono nato a Ragusa nel ’51, la mia famiglia è piuttosto piccola, quand’ero bambino i pochi parenti di mio padre erano negli Stati Uniti; mia madre, invece, aveva genitori e sorelle che sono stati per me un allargamento della mia famiglia. Sono stato il primo figlio di tre sorelle e, fra l’altro, maschio in una famiglia dove abbondavano le femmine. Quando venivano le feste, Natale, Capodanno, i morti (A Ragusa i giocattoli li portano i morti e non Babbo Natale), avevo tutto l’affetto che un bambino può desiderare; insomma ho vissuto nel lusso.
Domanda: sei stato in Sicilia fino a quando? Hai studiato anche in Sicilia?
Aparo: Ho studiato in Sicilia fino al liceo, dove ho perso un anno. Dopo il diploma sono andato in Germania a studiare, ma, tra l’anno perso e il tempo speso in Germania per gli esami di lingua, non ho fatto in tempo a chiedere il rinvio per il militare, che ho dovuto iniziare quindi quando avevo ancora 20 anni. L’ho fatto a Roma dove ho frequentato anche l’università. Dopo la laurea, a 26 anni, sono venuto a Milano, dove vivo ancora oggi.
Domanda: hai cominciato la tua professione subito in carcere?
Aparo: il carcere è arrivato dopo due anni che vivevo a Milano. Conclusa l’università, nel 1977, mi sono dato da fare per lavorare e, tra le tante cose, ho anche avanzato la richiesta per lavorare in carcere. Inserito nell’elenco degli esperti ex art. 80, ho cominciato a fare lo psicologo a San Vittore nel ‘79. Prima, per guadagnare qualcosa, avevo fatto ricerche di mercato e supplenze nelle scuole medie.
Domanda: cosa hai trovato in carcere? Cosa ti è piaciuto e cosa no di quell’inizio del ’79?
Aparo: Per i primi due anni ho fatto delle ore anche nel carcere di Varese, poi solo a San Vittore. Non è che amassi particolarmente lavorare con i detenuti, ma, visto che ero là, ci parlavo e giorno dopo giorno mi sembrava di capirci qualcosa. Degli inizi ricordo qualche conflitto con un direttore, il dott. Cangemi. C’erano i vetri della finestra rotti nella stanza dove incontravo i detenuti e dove stavo 4 ore seduto con 13 gradi a congelare, ma lui diceva che bastava mettere la maglia di lana. Per fortuna c’era una vice direttrice della quale sono stato e sono molto amico, Giovanna Fratantonio; forse è anche responsabilità sua se ho continuato a lavorare in carcere. Negli anni ho sfiorato tanti direttori con cui avevo scarsi rapporti fino a quando è arrivato Luigi Pagano con il quale sono riuscito a comunicare meglio. Tra l’altro, il Gruppo della trasgressione è nato quando c’era lui; non fosse stato così, credo che non sarebbe mai partito.
Domanda: in teoria, sei quello che da più tempo frequenta San Vittore quindi è importante per me capire che cosa è cambiato in questi lunghi anni. Cosa ricordi dei primi anni e come è cambiato il tuo lavoro in questi anni in carcere?
Aparo: credo che il carcere sia un mondo in cui il direttore incide pesantemente su tutto; non è come un treno che, se deve fare la tratta Milano-Roma, la fa abbastanza indipendentemente dalle idee politiche del capotreno. Detto questo, c’è stato un tempo in cui qualche volta uscivo dall’ufficio e vedevo per terra un laghetto di sangue; era l’epoca in cui i conflitti fra detenuti venivano “risolti” a coltellate, ancor di più i contrasti tra detenuti comuni e detenuti per reati sessuali. I miei primi anni a San Vittore sono stati anche caratterizzati dalla presenza delle BR. Le BR non ammazzavano in carcere le persone, ma contribuivano a mantenere un clima vivace… una volta alcuni di loro mi hanno pure mezzo sequestrato per un paio ore. Poi mi hanno lasciato andare perché abbiamo concordato pacificamente che la cosa avrebbe comportato danni per tutti.
Per quello che avveniva a quei tempi, nei miei primi 18 anni ho svolto il mio ruolo più o meno normalmente, cioè facevo con i detenuti dei colloqui in previsione di una relazione finalizzata al programma di trattamento; questo faceva lo psicologo ex art. 80! Oggi ci sono molti più psicologi e con i detenuti si può avere un rapporto meno frettoloso. Negli anni ho visto passare generazioni di psicologi e affini. Dico “affini” perché gli “esperti ex art. 80” potevano essere criminologi, psicologi e sociologi. Ma in pratica questi “esperti”, pur con professionalità nominalmente diverse, facevano la stessa cosa, o meglio, facevano quello che passava loro per la testa, senza alcuna indicazione su come procedere.
Una cosa che da subito mi ha molto colpito in carcere è che non c’è mai stato qualcuno che indicasse cosa ci si aspetta da uno psicologo. Si dovevano produrre le relazioni, ma non si è mai discusso né sono mai stati indicati i criteri per scriverle. Non credo che adesso sia molto diverso. In 41 anni di esperienza non ho mai sentito di un gruppo di studio dove ci si chiedesse come procedere nel colloquio con i detenuti e poi nella stesura della relazione. Dopo i primi 18 anni di lavoro, mi sono detto che, per cominciare a capire cosa passava per la testa dei detenuti, sarebbe stato il caso di provare qualcosa di alternativo e da lì è nato il Gruppo della Trasgressione.
Domanda: A un certo punto tu hai cominciato a pensare al gruppo ma anche alla società esterna che entrava in carcere
Aparo: quello che nei primi 18 anni di esperienza avevo sentito dire ai detenuti mi suggeriva che loro sapessero e si chiedessero ben poco in merito alla vita delle persone che lavorano, tabaccai e cassieri compresi. E dunque, sì, fra i primi obiettivi del gruppo c’era e c’è quello di favorire un confronto costante e battagliero fra detenuti e comuni cittadini. In questo sono stato avvantaggiato dal fatto che nel gruppo c’era Sergio Cusani, che era un polo di attrazione un po’ per tutti, dentro e fuori.
Il gruppo era appena nato e già arrivavano persone di ogni genere, cantanti del calibro di Ornella Vanoni, Enzo Jannacci, Roberto Vecchioni; presentatori televisivi come Fabio Fazio o Chiambretti; giornalisti come Enzo Biagi, filosofi come Gianni Vattimo e Massimo Cacciari, genetisti come Edoardo Boncinelli, teologi, medici, antropologi e tanti nomi importanti di diversi settori. Diverse volte era venuto anche un virologo di cui ero amico. Ognuno di loro parlava della propria materia e cercava insieme con me e con i detenuti quali collegamenti si potessero cogliere, quali analogie si potessero far fruttare, in termini di conoscenza o anche solo di pura suggestione, fra alcuni aspetti delle rispettive materie e la spinta dell’uomo a trasgredire.
Di certo queste persone non venivano per me; a portarli dentro erano Sergio Cusani ed Emilia Patruno, giornalista di Famiglia Cristiana. Con loro due e con un avvocato, a sua volta detenuto e molto motivato, il gruppo è partito a tutta velocità. Sergio Cusani e l’avv. Spada hanno avuto un ruolo fondamentale nel motivare gli altri detenuti a impegnarsi in modo sistematico. Ogni settimana loro due scrivevano il verbale delle riunioni e ogni settimana, grazie anche a Emilia Patruno, arrivavano al gruppo nuovi stimoli importanti, spesso anche parenti di vittime: Paolucci, il padre di un bambino ucciso da un pedofilo; la Bartocci, moglie di un gioielliere assassinato; la Capalbio, sorella di un tabaccaio ucciso durante una rapina.
Domanda: Il carcere non ti ha mai dato obbiettivi perché non li dà mai a nessuno, però tu quando hai pensato al gruppo avevi sicuramente un obbiettivo o più obbiettivi, in particolare cosa volevi da quel gruppo in cui hai investito e investi un sacco di energie e competenze?
Aparo: accanto all’obiettivo di favorire il confronto col mondo esterno, direi che il gruppo è nato perché non volevo che i detenuti parlassero con me solo in funzione della relazione da inviare al magistrato. Uno che fa lo psicoterapeuta è abituato a parlare con persone che ti confidano i loro pensieri, le loro paure perché hanno bisogno di essere aiutate, non perché hanno bisogno di uscire dal carcere. Fare psicoterapia significa aiutare le persone a dialogare con i propri conflitti e questo all’epoca in cui a San Vittore c’era uno psicologo per oltre 1000 detenuti era certamente impossibile. Per il detenuto, anche in considerazione del poco tempo che c’era per parlarsi, risultava molto più facile raccontare o inventare quello che nella sua fantasia avrebbe dovuto indurre lo psicologo esaminatore a scrivere una relazione favorevole alla misura alternativa.
Mi si potrà osservare che uno psicologo bravo dovrebbe essere capace di andare oltre quello che il paziente gli dice. Sarà pure, rispondo io, ma, fin quando il detenuto è essenzialmente una persona che vuole uscire dal carcere, egli non potrà essere un paziente e lo psicologo non potrà essere uno psicoterapeuta, cioè il partner di una ricerca condotta in due. In pratica, sto dicendo che dovresti riuscire a motivare il detenuto, almeno nel tempo del colloquio, a comportarsi da paziente, nonostante le serrature che egli vede attorno a sé lo inducano a guardare il mondo da carcerato. Ma questo è molto difficile se l’unica ragione per cui detenuto e psicologo entrano in contatto è costituita dalla relazione per il magistrato e se a commissionare la relazione è la direzione del carcere.
Proprio per questo, un certo giorno del settembre del ’97, dopo avere raccolto con l’aiuto di Sergio Cusani una ventina di detenuti attorno a un tavolo, il gruppo è nato con un discorso esplicito e abbastanza rude, che suonava più o meno così: <<cari signori, da 18 anni ho colloqui con detenuti di questo carcere, ma vi sento dire cose superficiali, quando non vere e proprie fesserie, e questo perché sapete che devo fare la relazione su di voi. Capisco che ognuno cerca di uscire dal carcere il prima possibile, ma in questo modo non mi diverto io e non ci guadagnate niente voi. Se volete, possiamo fare un gruppo di discussione che ha come scopo quello di entrare nelle vostre storie, di tornare ai tempi delle vostre prime trasgressioni e di provare a capire voi, ancora prima di me, com’è possibile che, pur essendo partiti voi tutti con l’idea di diventare qualcuno e, all’occorrenza, commettere reati per migliorare la vostra condizione, oggi voi siete qua in galera e i vostri figli sono mezzo orfani>>
In generale, l’attività del gruppo era anche un modo per far sì che il tempo del carcere non fosse solo il “tempo dell’attesa”. I 18 anni precedenti alla nascita del gruppo mi avevano fatto capire, infatti, che per i detenuti il tempo passato in carcere veniva conteggiato principalmente in relazione alla distanza dal fine pena. Di quegli anni a San Vittore ricordo ben poche iniziative, una era quella della Patruno, Il giornale “Il Due”; ricordo anche l’associazione di “Incontro e presenza”.
Ma tornando al gruppo, i primi due obiettivi erano: fare in modo che i detenuti si interessassero a loro stessi e alimentare una comunicazione tra dentro e fuori. Poi c’era anche il terzo obbiettivo, quello di fare in modo che i detenuti, conoscendo meglio se stessi, potessero contribuire a migliorare il funzionamento dell’istituzione. Un obbiettivo ambizioso, forse velleitario, un po’ da don Chisciotte. D’altra parte, come potevo sopportare che sia i detenuti sia le figure istituzionali continuassero a ripetere che dal carcere si esce più delinquenti di quando si è entrati?
E così, paradossalmente, un po’ per conoscere se stessi, un po’ per cambiare il carcere, una ventina di detenuti di San Vittore si sono messi a indagare sul perché delle loro prime trasgressioni e sono diventati miei alleati e partner di ricerca molto di più delle figure istituzionali. Alcuni di quei detenuti sono ancora oggi miei amici. L’istituzione, visto che non facevo male a nessuno, me lo ha lasciato fare, pur senza mai interessarsi, almeno per i primi 10/12 anni a quello che facevo. Negli ultimi cinque o sei anni qualche piccolo sostegno è arrivato con Siciliano, fino a tre anni fa direttore del carcere di Opera, e oggi con Di Gregorio, attuale direttore di Opera. Nel carcere di Bollate, l’attività del gruppo è finanziata dall’ASST Santi Paolo e Carlo, di cui sono consulente da una decina d’anni.
Domanda: chiunque stando in carcere peggiora, questo vale anche per gli operatori, i direttori. Io spesso mi pongo questa domanda, com’erano prima questi soggetti, prima di fare 10/20 anni dentro il carcere?
Aparo: quello del direttore è un mestiere che rischia, anche per le persone equilibrate, di far diventare chiunque una specie di Napoleone che si bea del suo potere, intanto che deve difendersi da attacchi che arrivano da tutte le parti. Ma è anche vero che di questi tempi esistono direttori che si appassionano al loro lavoro, che si adoperano per far si che il tempo del carcere sia di costruzione della propria libertà e non di attesa del fine pena. Anno dopo anno, almeno nelle carceri che frequento io, questo avviene sempre di più.
Fino a una ventina d’anni fa, invece, il carcere era in prima istanza controllo, doveva innanzitutto evitare che i detenuti scappassero, si suicidassero, si ammazzassero fra di loro, introducessero all’interno oggetti illeciti, ecc. Insomma, per garantire che non succedesse nulla di male, molti direttori preferivano (e non escludo che in molte parti d’Italia sia ancora così) chiudere quante più porte possibile, pur se, in questo modo, ad essere garantita era soprattutto la morte della mente, la morte emotiva e quindi anche la morte del cittadino, dell’uomo. E’ chiaro che il carcere non può eliminare del tutto il controllo, ma si dovrebbe considerare che se tu affidi il compito di controllare a una persona dall’equilibrio un po’ precario, il controllo diventa una smania, una malattia autorizzata, che esaspera i rapporti e che fa impazzire sia l’agente che controlla sia i detenuti controllati.
Insomma, il carcere è stato soprattutto un mondo che induceva operatori e detenuti più a difendersi che a progettare. Oggi si sta cominciando a capire, quantomeno da parte dei direttori che conosco io, che la migliore e più duratura garanzia viene da una progettualità di cui i detenuti stessi siano interpreti e, possibilmente, registi. E io conosco, effettivamente, molti detenuti che sono diventati in carcere registi di attività e delle loro vite, contribuendo in tal modo anche alla stabilità e all’evoluzione di altri detenuti.
Domanda: che cosa salvi del carcere e qual è il ricordo più positivo che hai in questi anni?
Aparo: del carcere salverei il fatto che dà un confine alle persone che non sanno fare della propria libertà un uso compatibile con quella degli altri, ma trovo indispensabile che, all’interno di questo confine, ci siano dei programmi studiati, organizzati e praticati assiduamente per condurre i ristretti a vivere entro confini più ampi e non imposti dall’esterno. È indispensabile che dopo una necessaria riduzione della libertà di azione, il carcere e le istituzioni ad esso collegate trovino il modo, e facciano assidui studi in tal senso, per motivare il detenuto a interpretare la propria libertà in modo più compatibile con quanto ci viene indicato dalla costituzione, dal buon senso e dalle ferite ricevute da chi aveva avuto in passato la disgrazia di incontrarlo.
Come si fa, dopo essere diventati delinquenti, a diventare cittadini? Dove sono gli studi che si occupano di questo? Forse si confida nell’idea che la persona che sta in galera, una volta condannata, possa cominciare a interrogarsi su se stessa e da sola trovare la risposta, ancora meglio se posta in isolamento! Ma se uno è ignorante come una capra e per giunta abituato a comportarsi come un bisonte, da dove dovrebbe arrivargli la scintilla?
In altre parole, apprezzo che il carcere riduca la possibilità di scorrazzare nella prateria del delirio d’onnipotenza, ma rilevo una sua colpevole miopia quando constato che l’istituzione si comporta come se dal delirio di onnipotenza, dalla coscienza polverizzata di chi uccide il tabaccaio, si potesse guarire semplicemente stando in cella ad attendere una luce divina che si fa strada fra le sbarre. Tutto l’apparato istituzionale che si occupa del reo (dall’arresto, al giudizio in tribunale, alla restrizione in carcere) sembra partire dal presupposto che chi pratica abitualmente il reato sia completamente consapevole, responsabile e intenzionato nel fare quello che fa e confida nel fatto che il delinquente, parlando con se stesso e con quelli che stanno in cella con lui, possa trovare dentro di sé tutte le risorse per cambiare sensibilità, idee, valori, intenzioni e comportamenti.
Magari nessuno lo pensa in modo sistematico, ma nel loro complesso, sembra che le istituzioni che si occupano di devianza facciano riferimento a un adolescente che comincia a drogarsi, a odiare le divise, ad abusare del proprio potere, dopo aver deciso a tavolino che queste debbano essere le sue aspirazioni primarie nella vita.
E si trascura che la pratica dell’abuso è il risultato di un complesso di fattori, fra i quali, uno dei principali è costituito da una sensazione fisica, umorale, che galleggia fra le palafitte del cervello dell’adolescente: cioè la sensazione che chi incarna il potere (il padre, chi indossa la divisa, la toga o chi viaggia in macchina blu) non sia degno del suo ruolo e, pertanto, che non esistono impegni verso se stessi, tanto meno verso gli altri, da onorare. Qualcuno, per completare il quadro, si convince che gli unici impegni che vale la pena osservare sono l’omertà e il mantenimento della contrapposizione paranoica con tutto quello che somiglia a una divisa.
Per quello che a me pare di aver capito, a far diventare delinquenti sono le sensazioni di un adolescente ferito, sfiduciato, arrabbiato e rancoroso, che poi, strada facendo, diventano idee deliranti, capaci di orientare l’azione di adulti che hanno perso la libertà di sentire, pensare e decidere, già a causa del loro rancore e della conseguente smania di vivere nell’eccitazione del potere e della droga.
In Italia abbiamo più di 200 carceri e ho ragione di credere che nella grande maggioranza di questi le problematiche di cui ho appena detto siano del tutto ignorate. E se questo è vero, capisco che tante persone, anche dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, finiscano per dire che il carcere non serve a nulla.
Da parte mia, credo che il carcere vada cambiato radicalmente, ma in qualche modo un sistema che impone confini a chi delinque in preda al proprio delirio ci deve essere. E il delirio, lo ribadisco, non è solo quello del boss mafioso; il delirio parte dagli umori dell’adolescenza che, strada facendo, si incancreniscono nello scontro con una realtà istituzionale che non sa motivare a cambiare rotta e che, anzi, contribuisce a rafforzare il delirio e a ossificarlo.
E allora quali ricordi buoni ho del carcere, visto che sono così critico? Il fatto che lo vedo cambiare! Collaboro con reciproca stima con un numero crescente di direttori, agenti e magistrati e mi sembra di condividere con loro idee e principi. Ma le cose cambiano troppo lentamente e inoltre è sempre troppo difficile individuare chi ha, in definitiva, la facoltà di decidere e attuare il cambiamento che tutti sembrano auspicare.
Nel mio piccolo, ho comunque dei bei ricordi e, ancor più che bei ricordi, ho i risultati che continuo a coltivare ancora oggi in collaborazione proprio con i detenuti che ho conosciuto in questi anni. Hanno nome e cognome e sono tanti; si chiamano Romeo Martel, Luigi Petrilli, Maurizio Piseddu, Roberto Cannavò… e in questo periodo in cui il Covid 19 ci costringe a usare le piattaforme on line per comunicare, ho visto e ho ripreso a lavorare e a giocare con numerosi ex studenti del gruppo e, cosa ancora più gratificante, con questi ex detenuti, oggi nuovi cittadini, che sono passati dal Gruppo della Trasgressione nei suoi 23 anni di attività.
Oggi sono questi nuovi cittadini a motivare e a fare appassionare gli studenti universitari attualmente in tirocinio con la nostra associazione: da una parte, si studiano insieme le problematiche, il divenire, la complessità degli intrecci che inducono l’adolescente a scivolare nel degrado; dall’altra, progettiamo iniziative capaci di sostenere il detenuto e l’adolescente a rischio di devianza nel suo cammino, nell’impegno e nella collaborazione con gli altri. Sì, la mia maggiore soddisfazione è quella di constatare che persone che hanno fatto parte del gruppo in carcere 8, 15 o 20 anni fa, oggi, pur avendo una famiglia e un lavoro e senza chiedermi soldi, collaborano con chi è ancora detenuto, con alcuni familiari di chi è morto per mano della criminalità e con gli studenti in tirocinio per trovare le parole e i mezzi per prevenire e contrastare il degrado soggettivo e ambientale che porta ad annichilire la propria coscienza e alla cosificazione dell’altro.
Torna all’indice della sezione – Alcuni video del gruppo



 Accompagnando per mano vittime e rei, la sfida che attende ciascuno di noi è dunque quella di contribuire ai percorsi riparativi dello strappo che il reato ha causato: perché, parafrasando il Poeta (Baudelaire), solo la danza può rivelare tutto il mistero che la vita tiene nascosto.
Accompagnando per mano vittime e rei, la sfida che attende ciascuno di noi è dunque quella di contribuire ai percorsi riparativi dello strappo che il reato ha causato: perché, parafrasando il Poeta (Baudelaire), solo la danza può rivelare tutto il mistero che la vita tiene nascosto.
 Ed in effetti fu proprio grazie alla lettura del libro “I pugni nel muro” che esattamente 20 anni fa aiutai un Professore di una scuola superiore a portare una sua classe nel carcere di San Vittore, perché ritenevo importante anche io – ai tempi solo un educatore, anche se laureato in giurisprudenza – che dei giovani potessero avere occasioni di “aprire gli occhi” sul mondo che li circondava.
Ed in effetti fu proprio grazie alla lettura del libro “I pugni nel muro” che esattamente 20 anni fa aiutai un Professore di una scuola superiore a portare una sua classe nel carcere di San Vittore, perché ritenevo importante anche io – ai tempi solo un educatore, anche se laureato in giurisprudenza – che dei giovani potessero avere occasioni di “aprire gli occhi” sul mondo che li circondava.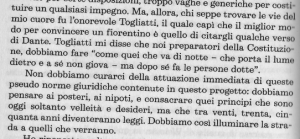
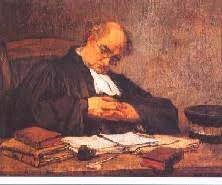 E invece, quanto al pubblico ministero…. lo lasciamo fuori dall’art. 27 comma 3 della Costituzione? Lo lasciamo fuori, a fare – permettetemi l’ironia – “il bello addormentato”? Ossia il magistrato che, come nel quadro di un celebre pittore francese dell’ottocento (Thomas Couture), se la dorme nel mentre? Ricordo peraltro a tutti che è il pubblico ministero, di regola, il primo “volto della giustizia” che il reo incontra sul suo percorso!
E invece, quanto al pubblico ministero…. lo lasciamo fuori dall’art. 27 comma 3 della Costituzione? Lo lasciamo fuori, a fare – permettetemi l’ironia – “il bello addormentato”? Ossia il magistrato che, come nel quadro di un celebre pittore francese dell’ottocento (Thomas Couture), se la dorme nel mentre? Ricordo peraltro a tutti che è il pubblico ministero, di regola, il primo “volto della giustizia” che il reo incontra sul suo percorso!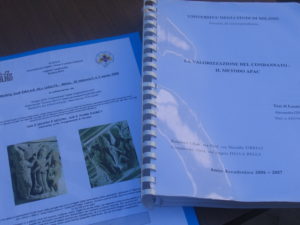
 In altre, e meno retoriche, parole: chi dovrà clonare il dott. Aparo? Chi dovrà saperne estrarre il DNA del suo metodo di lavoro? Chi dovrà continuare a tenere acceso quel “lume”, a cui Dante faceva riferimento, verso questa direzione già intrapresa e ben fino ad ora sperimentata?
In altre, e meno retoriche, parole: chi dovrà clonare il dott. Aparo? Chi dovrà saperne estrarre il DNA del suo metodo di lavoro? Chi dovrà continuare a tenere acceso quel “lume”, a cui Dante faceva riferimento, verso questa direzione già intrapresa e ben fino ad ora sperimentata?





