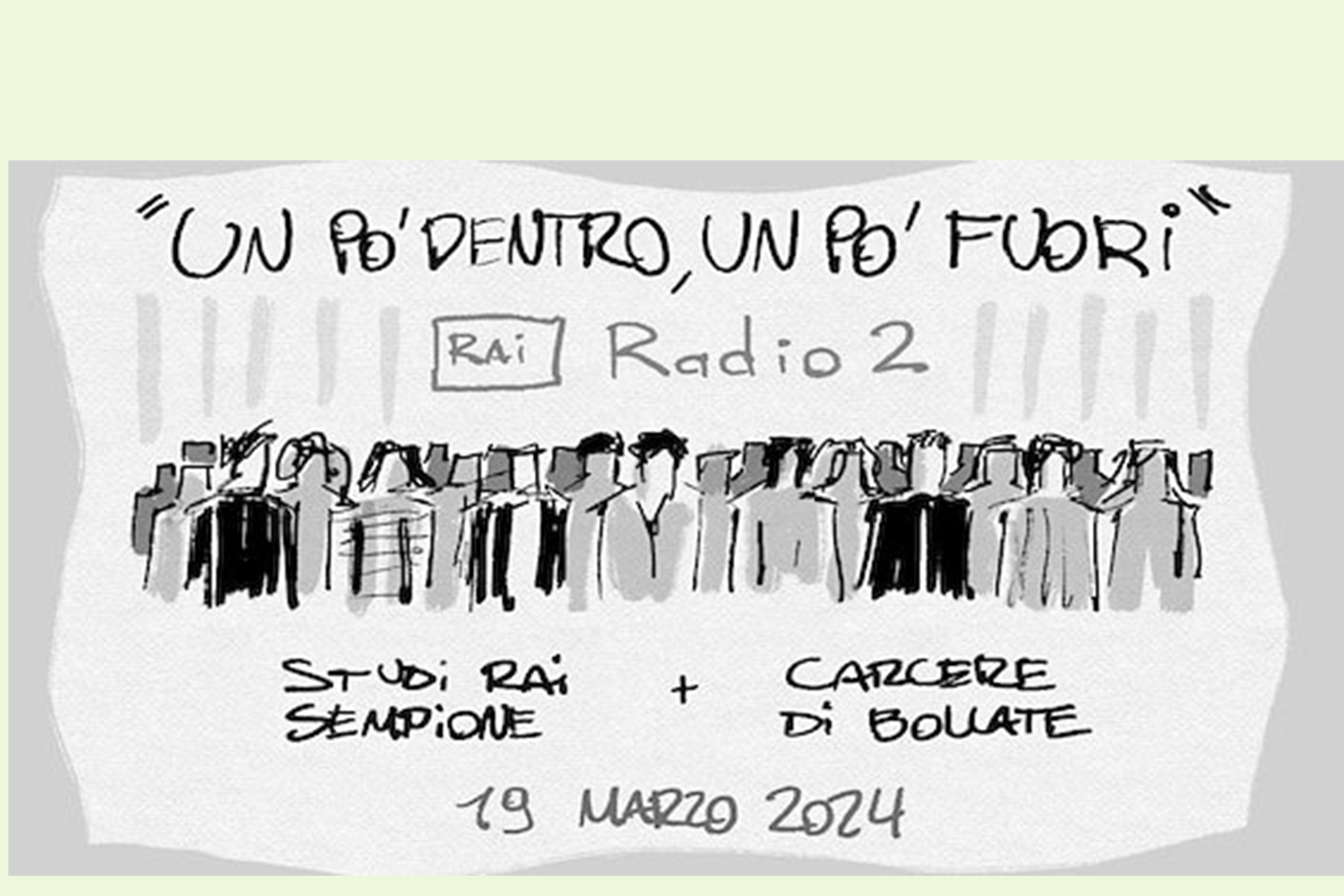“In carcere?!”
E’ questa la reazione media delle persone alle quali racconto dell’esperienza alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, tutte tra lo stranito e il preoccupato per il mio entusiasmo all’idea di mettere piede (e testa) in un luogo del genere.
Mi sono resa conto sempre di più che il carcere è un mondo a porte chiuse, dall’esterno è pressoché impossibile comprendere lo slancio e la voglia, quasi l’urgente bisogno di chi cerca di rendersi utile in tale ambiente. Di chi cerca, in sostanza, di fare il proprio dovere di cittadino.
“Tanto le persone non cambiano, non ne vale la pena.”
“Ma non hai paura a stare o a parlare con loro?”
“E’ un mondo così pesante, ma chi te lo fa fare?”
Penso che ciascuno di noi potrebbe molto contribuire all’elenco di luoghi comuni e pregiudizi che sente ogni giorno appena pronuncia la fatidica parola “carcere”. Tuttavia, proprio per questo motivo è importante parlarne. Ammetto di avere provato anche un po’ di soddisfazione nel vedere nelle facce di amici, parenti e addirittura un taxista tanti bei preconcetti un po’ messi in discussione al sentire cosa stavamo portando avanti a Opera.
Ci sono esperienze che segnano un prima e un dopo e, senza dubbio, “Delitto e castigo” è tra queste. L’impatto umano di questi incontri mi ha segnato profondamente.
Innanzitutto, sento di dover ringraziare gli ideatori di questo progetto, Cajani e Juri, perché ci hanno insegnato a crederci. E’ difficile pensare di poter cambiare il mondo, però si può certamente cambiare il pezzetto di terra che ci circonda. Basta “semplicemente” volerlo e attivarsi in tal senso, con onestà e dedizione, come ci è stato mostrato.
Il dott. Nobili è stata una presenza rassicurante, non solo per l’enorme esperienza da elargire, ma anche perché ha reso tangibile il fatto che sia possibile fidarsi delle istituzioni, anche se non di tutte. Sono “credibili, serie, rispettose e rispettabili” solo le istituzioni costituite da uomini e non da funzionari. Credo che per avere anche solo una vaga idea di chi sia il dott. Nobili bastino le parole di Emanuele, uno dei detenuti, che durante uno degli incontri ha reso noto allo stesso magistrato che all’interno del carcere egli viene definito “severo, serio e umano” dagli stessi detenuti.
Banalizzando e pensando allo schema di un gioco come ‘guardie e ladri’, credo non sia affatto scontato il riconoscere l’uomo dentro a chi, dal tuo punto punto di vista, ti dà la caccia: chi nella tua storia ha il ruolo del cattivo.
Sorge spontanea una domanda: cosa ho imparato?
Innanzitutto, ho imparato fin dove si può arrivare. L’ultimo incontro è stato scandito dalle parole di Juri che cercava in ogni modo di farci riflettere su quale fosse il bagaglio culturale e di esperienza che avremmo portato a casa a fine ciclo di incontri. A parer mio, il fulcro è che tutti possono cambiare, ma non tutti vogliono. Di conseguenza, il nostro compito è quello di far vedere ai detenuti che ci sono alternative, che c’è una seconda possibilità anche per loro, ma che dipenderà proprio da loro il coglierla o il continuare a vivere nell’irrimediabile antitesi tra la “società degli esclusi” e la “società di quelli che escludono”, cioè, a parer loro, noi.
Un carcere che funziona punisce perché deve, ma responsabilizza perché vuole. I detenuti, nella maggior parte dei casi, poi rientreranno in società, quindi è assolutamente necessario far capire loro che diritti e doveri vanno di pari passo e che, per partecipare a pieno titolo ad un determinato “gioco”, è fondamentale rispettarne le regole. Allo stesso modo, è necessario trovare chi queste regole sia disposto a insegnargliele, con pazienza e cercando di parlare “la loro lingua”, e poi trovare chi sia disposto a “giocare” con loro.
Fuor di metafora, è nostro compito tendere loro una mano, convincerci e far comprendere alla società civile che il carcere non è un posto dove parcheggiare gente scomoda, in attesa che ci si scordi di loro, perché tanto loro non saranno mai come noi. Il carcere è un male necessario, ma non sufficiente affinché i detenuti si ricordino di essere e si riconoscano uomini, con tutto ciò che questo comporta nei confronti di se stessi e degli altri.
Credo che la vera sfida arriverà quando dovremo essere noi a condurre i detenuti, sin dall’inizio, lungo questo tortuoso percorso, perché finora noi abbiamo visto se non percorsi conclusi, per lo meno percorsi iniziati.
Ho anche imparato che ho ancora tanto da imparare. Indipendentemente da quale sarà il mio specifico ruolo nel mondo del Diritto, per essere credibile, seria, rispettosa e rispettabile come persona credo di aver bisogno di confrontarmi ancora con chi ci è riuscito, che si tratti di magistrati che vivono il proprio ruolo e le proprie responsabilità in un certo modo o di familiari di vittime che non hanno demonizzato e anzi hanno teso una mano. Ci sono poi i detenuti, che stanno con fatica imparando a mettersi in discussione e a “osservarsi dall’esterno”, ora con gli occhi dei familiari delle vittime, ora con quelli dei magistrati, ora con quelli degli studenti, ora con quelli dei loro stessi familiari.
Questa molteplicità di punti di vista, che io ho avuto la fortuna (e in alcuni casi l’onore) di vivere in prima persona, dovrebbe essere la prassi e non l’iniziativa che fa scalpore a livello nazionale. E’ necessario che la società entri in carcere e che chi sta dentro al carcere esca fuori. E’ necessario ricordarsi che le mura del carcere hanno delle porte e che queste porte vanno usate.
“Chi sono io? Perché sono così? Che genitori ho avuto? Che incontri ho avuto? Cosa voglio farne di ciò che sono?”
Questi interrogativi di Cajani durante uno degli incontri mi colpirono profondamente, facendo anche riaffiorare qualche reminiscenza liceale sul contrasto tra Nomos e Physis.
Un discorso è chiedersi chi sei, altro è chiedersi cosa tu decidi di fare con ciò che sei. Credo non sia affatto indifferente o scontata la presa di responsabilità e consapevolezza che implica e consegue all’accettare che abbiamo non solo la possibilità, ma anche il dovere e la responsabilità di scegliere. Fare i conti con cos’hai fatto e con cos’hai fatto di te stesso ritengo sia il fulcro del percorso rieducativo dei detenuti.
L’ultimo elemento sul quale mi soffermerò è un aspetto sul quale non avevo mai realmente riflettuto prima di questi incontri: il mondo della Giustizia è profondamente, quasi intrinsecamente, permeato di dolore. Dolore di chi subisce. Dolore di chi commette, perché significa che c’è una sottostante situazione di disagio più o meno consapevole. Dolore di chi condanna, perché non si priva qualcuno della libertà a cuor leggero. Dolore di coloro che stanno accanto a tutte queste persone.
Probabilmente anche per questo motivo, maggiore è il livello di consapevolezza che si prende di tali dinamiche ed equilibri (o forse squilibri), più quell’illusione di poter fare del bene diventa un’urgenza, un bisogno quasi spasmodico di toccare personalmente con mano ciò che non funziona e provare ad aggiustarlo.
Tra tutti, sono sicuramente quelli con Marisa e Paolo i due incontri che più mi hanno segnato. A seguito di un reato, mentre il pubblico è concentrato sul reo (rischiando di alimentare le sue manie di protagonismo), la vittima spesso priva di nome passa subito in secondo piano, priva di una qualsiasi caratterizzazione o attenzione. Il reo è una persona, la vittima è un’ombra. Figurarsi i familiari di quest’ultima.
Marisa e Paolo hanno invece dimostrato con il loro vissuto che probabilmente è proprio loro il ruolo principale nel percorso rieducativo dei detenuti. L’impegno profuso in iniziative come questa, il coraggio di ascoltare e instaurare una reale comunicazione con chi alle parole ha sempre preferito altri mezzi, la forza di tendere loro la mano e il profondo e sincero rispetto con cui li ho sempre visti trattare i detenuti sono qualcosa di incredibile.
Vedere Marisa abbracciare i detenuti, vedere questi ultimi provare nei suoi confronti quello che potrei definire sincero affetto e sentire lei stessa interrogarsi su come fosse possibile per lei essere diventata in un certo senso amica di alcuni di loro: serve tempo per metabolizzare a pieno tutto ciò, per comprenderne fino in fondo il peso e il valore.
Quest’esperienza più che risposte, perché infatti me ne ha date ben poche, mi ha piuttosto regalato domande e uno sprone a pormene altre ancora. E’ bene interrogarsi su tutto ciò che ci circonda e, soprattutto, su chi ci circonda. Lo stesso dott. Nobili ha sottolineato quanto sia importante vivere nella cultura del dubbio.
E tra tutti gli interrogativi che dopo quest’esperienza continueranno ad accompagnarmi per un bel po’, ce n’è uno in particolare per il quale, mio malgrado, non riesco a trovare neanche un principio di risposta: dove si trova il coraggio di non lasciarsi incattivire dal dolore?
Elena Tribulato
Delitto e Castigo