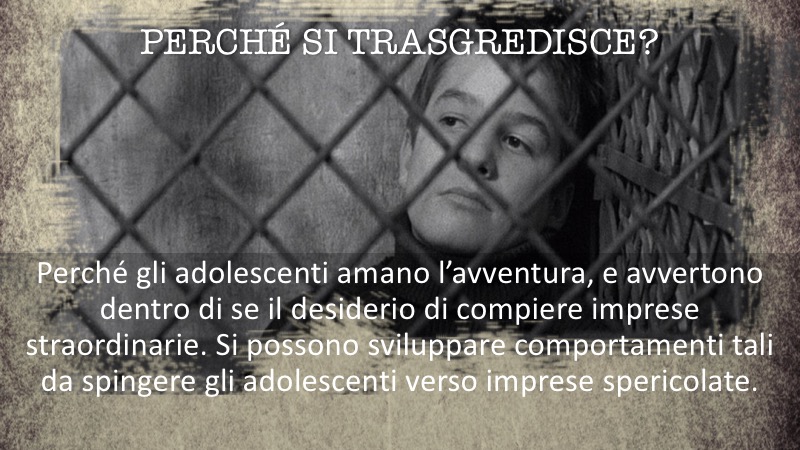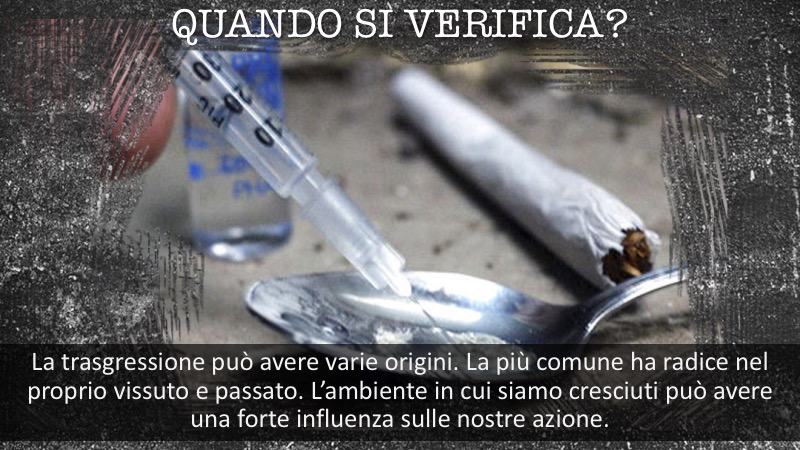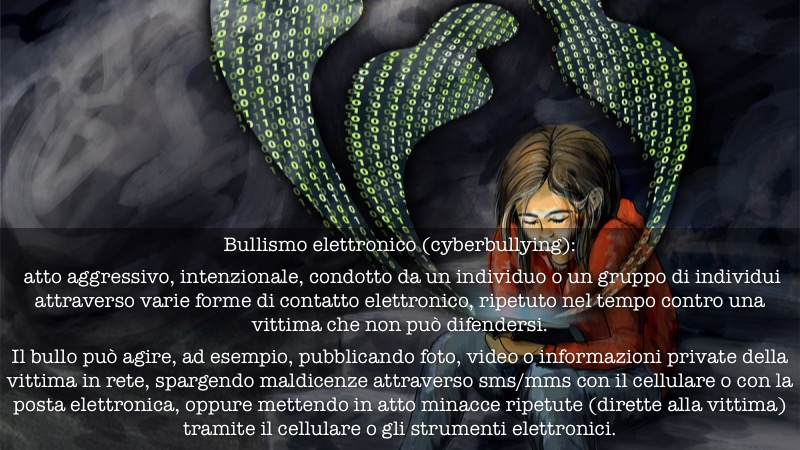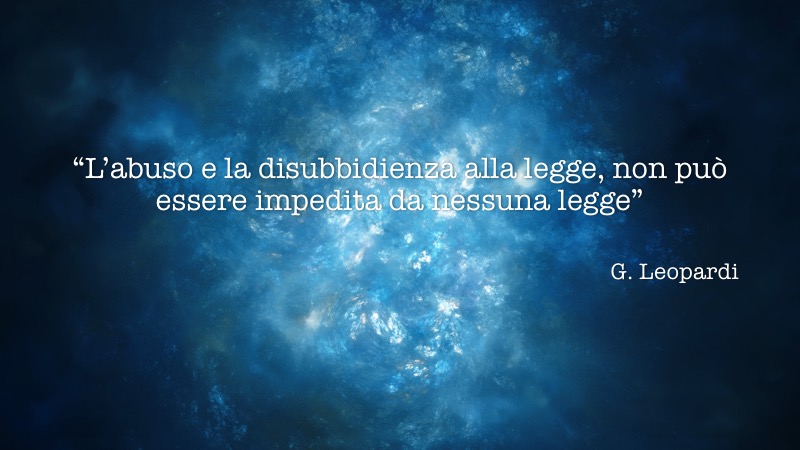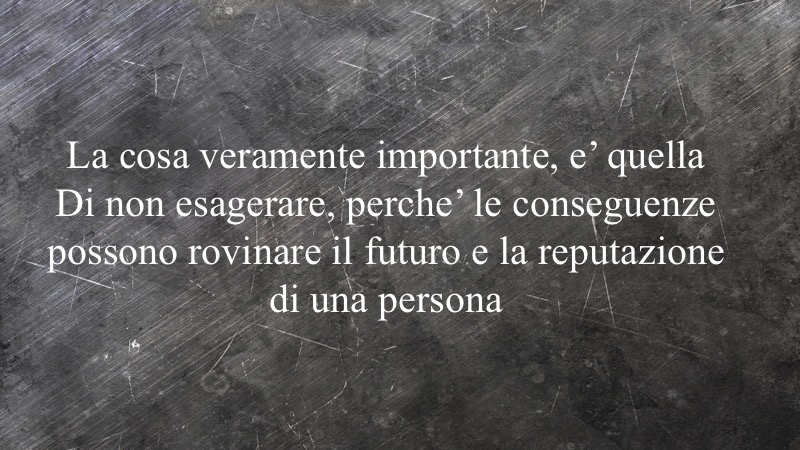Qualche tempo fa il Gruppo della Trasgressione aveva preso parte nel carcere di Opera a un incontro sul rapporto fra vittime e autori di reato. Il confronto, cui avevano preso parte anche magistrati e giornalisti, era stato giudicato da tutti i presenti interessante, ma più di una persona aveva osservato con bonaria ironia che… “mancavano i carnefici”.
Non potevo non convenirne! Anche se erano loro stessi a dire che “… all’epoca dei reati, non avevamo lo spazio dentro per sentire la vittima”, i detenuti che avevano preso la parola sembravano ben altro da quello che avevano dichiarato di essere stati all’epoca dei loro crimini. Dicevano apertamente che “quando non si dà valore alla propria vita, non si può avere coscienza del dolore della vittima”, ma il loro modo di parlare sembrava guidato proprio dalla coscienza e dal gusto di viverla e di ricercarla.
D’altra parte, essi erano tutti parte di un gruppo di studio dove si cerca di comprendere: 1) come si diventa criminali; 2) il modo confuso con cui il principio della giustizia è presente anche nel predatore; 3) se e come si può rinunciare gradualmente all’eccitazione dell’abuso per il piacere della relazione; 4) quanto sia difficile stabilizzare l’equilibrio psico-sociale del neo-cittadino proveniente da un’adolescenza vissuta nella devianza.
Dopo avere ascoltato per anni i loro contributi, oggi credo che dietro ogni gesto criminale ci sia un genitore al quale il reo fantastica di restituire un tradimento subito. Ma la trama storica e psicologica che dà origine a queste fantasie e gli atti criminosi che ne discendono sono difficili da ricostruire; e così, spesso si trascura che rancore, reato e fantasie di rivalsa fanno parte di un impasto tumultuoso, spesso artificiosamente glaciale, nel quale l’abuso e la violenza hanno per chi li esercita il sapore del risarcimento.
Ma proviamo a entrare in questa oscura selva di fantasie negate! Da più di un detenuto era stato detto che nell’atto del reato “… la vittima non è una persona, ma solo… un ostacolo da eliminare”, in altre parole, un oggetto col quale non si vive alcuna relazione affettiva. Pur se in presenza di diverse vittime di reato, parlando dei loro crimini, i detenuti avevano confidato che “… è brutto dirlo, ma io alla vittima non ci pensavo, non provavo nulla”.
A me pare però che le loro affermazioni corrispondano solo a un frammento di verità… e mi sembra, piuttosto, che fra chi commette il reato e chi lo subisce esista una relazione molto più intensa, pur se sotterranea, che somiglia a quella che il bullo ha con la sua vittima e, prima ancora, a quella che la bambina ha con la sua bambola quando la sgrida. Mi sembra, insomma, che la vittima sia per il reo un “oggetto” molto meno estraneo di quanto egli senta coscientemente e sia, come per il bullo, il supporto sul quale egli proietta in modo espulsivo la sua fragilità e il suo senso d’impotenza, cioè un fratello al quale far pagare il tradimento subito (o che fantastica di aver subito) dalle persone deputate a proteggerlo e gli stati d’animo che ne discendono: rancore, senso di emarginazione, difficoltà a muoversi nella legge del padre, implicita autorizzazione alla pirateria.
Ma recuperare la coscienza della parentela negata fra il reo e la vittima è per tutti un percorso in salita, che equivale a perdere i vantaggi dell’abuso, senza la certezza di guadagnare qualcosa in cambio! L’abuso, per il reo, corrisponde a una rivolta contro il tiranno, a un delirante flash di libertà, a un’affermazione della propria onnipotenza; per il comune cittadino, a un sistema per identificare i tratti del persecutore e tenerlo distante; per i giornalisti, a un banchetto cui invitare quante più persone possibile; per il tribunale, a una violazione di cui restituire il peso a chi l’ha commessa e i conteggi ai cittadini; per la vittima, a un trauma che toglie il fiato e placca il pensiero.
Insomma, interpretare l’abuso come l’indicatore di una parentela (e non solo di un conflitto fra estranei) è un’operazione difficile, costosa, temeraria. Eppure, dopo qualche tempo dallo shock, qualcuno si mette in cerca di questa parentela; e a farlo, è proprio la vittima o i suoi congiunti più cari… forse, semplicemente perché sono proprio loro ad avere il bisogno più sentito di “istruire una prossimità”.
Quando un bullo umilia un suo coetaneo estorcendogli un panino, lo sottomette per avere il panino o gli prende il panino per umiliarlo? E il suo bisogno di umiliare la vittima da cosa nasce?
La scena dell’abuso, nella gran parte dei casi, può essere riassunta come quella di una vittima costretta all’impotenza da chi, pilotato dall’odio verso chi lo ha reso a sua volta impotente, ha bisogno di espellere la propria vulnerabilità. Il bottino, che nell’opinione comune è la meta del reato (ma che non a caso viene consumato in un baleno), credo sia soprattutto un diversivo per coprire che l’obiettivo del reato è ottenere un’ennesima conferma (che però non basta mai!) d’essere così invincibili da non potere essere sottomessi, tanto duri da potere sfidare il fantasma di un genitore castrante e/o latitante, tanto indipendenti da potersi lasciare alle spalle la propria impotenza, delegandola, una volta per tutte, alla vittima. Qualcuno lo fa umiliandola, qualcuno offrendo un bicchiere d’acqua a chi sbianca per la paura nel corso di una rapina, ma è ancora un sintomo… e i sintomi, si sa, ritornano mille volte proprio perché non se ne riconosce il messaggio, costringendo il loro “esecutore” a girare dentro un loop da fare invidia a Sisifo.
Le persone detenute che avevano offerto le loro considerazioni nel corso dell’incontro, invece, sembravano motivate a interrogarsi sull’origine dei loro sintomi e sull’humus dei loro reati quanto gli altri protagonisti della ricerca, vittime e magistrati compresi. Fra di loro, uno confidava che un tempo pensava di essere diventato adulto il giorno in cui ha picchiato suo padre, e che in tempi più recenti si era invece reso conto che essere adulti è una meta verso la quale, nella più sorridente delle ipotesi, si procede intrecciando il piacere della libertà con il piacere della responsabilità verso l’altro.
Finalmente possiamo rallegrarci, almeno con alcuni, del fatto che le stesse persone che in passato sono state carnefici oggi ci aiutano a ricostruire il mosaico dell’identità deviante e a toccare con mano che, quando l’arbitrio e l’eccitazione diventano il principale strumento per zittire il proprio senso di marginalità, il reato può investire chiunque, come chiunque può essere investito da un autista ubriaco o da un burattino intontito dal delirio di un’indipendenza posticcia.
Ma se perdere un figlio per un incidente, per una disgrazia priva di intenzioni, causa dolore e sgomento, perderlo per volontà di una marionetta mossa dal delirio, comprensibilmente, genera un tormento che non si placa. Chi perde un congiunto rimane legato per tempi lunghissimi all’omicida. Quasi sempre, in un primo momento, la vittima sviluppa verso il colpevole odio e voglia di vendetta; poi, molte volte, passa al desiderio che il processo gli “restituisca” la giusta punizione; infine (ma qualche volta anche in tempi molto brevi), soprattutto per chi a causa del reato ha perso un congiunto, accade che il desiderio di giustizia si trasforma nel desiderio che il reo possa sviluppare la coscienza della perdita causata. Ricordo le parole straziate della moglie di una delle vittime della strage di Capaci al funerale: “Io li perdono, ma loro si devono inginocchiare… ma lo so, loro non si inginocchiano”. Perché questo bisogno così intenso che la persona che ci ha ferito abbia coscienza del nostro dolore? Perché questo bisogno di far pace con gli assassini del marito?
Probabilmente, anche dopo che il male ha ultimato il suo corso, nessuno quanto la vittima ha bisogno che nel carnefice nasca la coscienza dell’altro. Sembra paradossale, ma molto spesso chi ha subito una perdita così grave ha bisogno di pensare al congiunto che ha perso la vita insieme con la persona che gliel’ha tolta, qualche volta persino di sentirla parte della sua stessa cerchia affettiva. Chi patisce il dolore ha bisogno che dal dolore nasca qualcosa e di orientarlo in una direzione… e questa direzione non può essere quella dell’odio… perché nel tempo la vittima capisce che la prigione dell’odio consuma la sua stessa vita senza restituirle nulla. La vittima capisce, potremmo aggiungere, quello che il carnefice ha difficoltà a riconoscere e che tiene distante da sé grazie all’eccitazione compulsiva di droghe e abusi di potere.
Si intuisce che aiutare chi subisce un reato a emanciparsi dalla ragnatela che quasi sempre ne avviluppa i pensieri è doveroso e funzionale per la salute sociale almeno quanto favorire l’evoluzione del reo. Ma perché chi ha subito il male ha così tanto bisogno che chi lo aveva causato ne abbia coscienza? Spessissimo vediamo le vittime spendere a tale scopo incredibili quantità di energia. Ricordo che circa 20 anni fa Luciano Paolucci, padre del piccolo Lorenzo, ucciso da un pedofilo, venne una domenica da Foligno a San Vittore senza altro compenso che la possibilità di riflettere col Gruppo della Trasgressione sul perché del male subito da suo figlio.
Credo che la lacerazione dovuta a una grave perdita affettiva, giunta traumaticamente e senza una comprensibile ragione, per potere essere tollerata, debba diventare seme di una storia: il terremoto non ha volontà, traumatizza, ma non chiude i sopravvissuti nella prigione del rancore; quando la morte viene determinata intenzionalmente, invece, i parenti più stretti della vittima, per poterne sopportare la perdita, hanno bisogno che la volontà dell’omicida cambi direzione, che l’odio mortifero diventi coscienza della prossimità e origine di nuove relazioni. Ma perché questa “gravidanza” possa essere avviata, occorre la ricostruzione di una storia che, di fatto, non conosce nemmeno il carnefice, se non nei suoi risvolti più superficiali e comunque non nei nodi che sono all’origine delle sue scelte; occorre una storia che conduca chi ha commesso l’abuso alla libertà di entrare in relazione con l’altro.
Con questo non si vuol dire che il reato viene commesso in una condizione di “illibertà”; è assiomatico che chi commette un abuso ne è responsabile. Ma se per la società non è possibile fare a meno del presupposto della responsabilità e se per la Legge è ragionevole misurare soprattutto la responsabilità nel reato, per la psicologia è importante interrogarsi sui meccanismi in virtù dei quali la persona allarga o restringe ogni giorno i confini della propria libertà. Per chi indaga sui retroscena della scelta, l’area della responsabilità riguarda anche la cura o l’incuria con cui ci si occupa della propria libertà di scelta e degli stati d’animo che ne costituiscono il liquido amniotico. Al Gruppo della Trasgressione, dove l’esplorazione di questi territori è pratica quotidiana, recentemente uno dei componenti diceva che “recuperare la coscienza del proprio delirio e del male perpetrato corrisponde a restituire alle vittime il dolore e il rispetto che meritano e a noi stessi il risveglio dall’anestesia nella quale abbiamo vissuto”.
Ascoltando le parole dei magistrati, dei giornalisti, delle vittime e di chi a suo tempo è stato carnefice, si percepisce, chiaro, il desiderio di tutti di recuperare coscienze esiliate; da parte mia, credo che per farlo occorrano storie che permettano alla “banalità del male” di disvelare la sua intelaiatura nascosta e corrosiva.
Per riuscirci, però, non basta perdonarsi e abbracciarsi; è indispensabile, tra l’altro, che l’immagine cristallizzata dell’autorità che di solito ha il criminale (quella di un tiranno che esercita il potere esclusivamente a proprio beneficio) venga rielaborata e bonificata. Ma questo diventa del tutto impossibile senza programmi mirati e se non si tiene conto del fatto che personaggi pubblici e, a volte, perfino figure istituzionali si lasciano sovrapporre al prototipo di autorità che chi commette abusi ha interiorizzato già nei primi anni di vita. Affinché una punizione e la restrizione della libertà possano essere tollerate senza diventare per il ristretto un’ulteriore autorizzazione alla pirateria, occorre che il condannato possa imparare a nutrirsi della relazione con l’altro, e questo è possibile solo se il dolore della punizione e la fatica di recuperare la coscienza esiliata vengono condivisi dall’autorità stessa (particolarmente interessante sul tema la relazione della dott.ssa Cosima Buccoliero al Teatro Dal Verme lo scorso 15 ottobre).
Per fortuna, pur se il rinnovamento del clima istituzionale avviene con lentezza, questa è la direzione degli ultimi anni. Avviare studi e aprire spazi strutturati in cui ci si possa servire della motivazione che hanno in tal senso le vittime di reato non può che giovare alla causa. È vero che la vittima ha bisogno di recuperare la prossimità col suo carnefice per tornare a vivere libera dal rancore, ma questo, oltre a essere un valore morale, è in definitiva ciò di cui abbiamo bisogno noi tutti (l’amicizia fra Claudia e Irene)