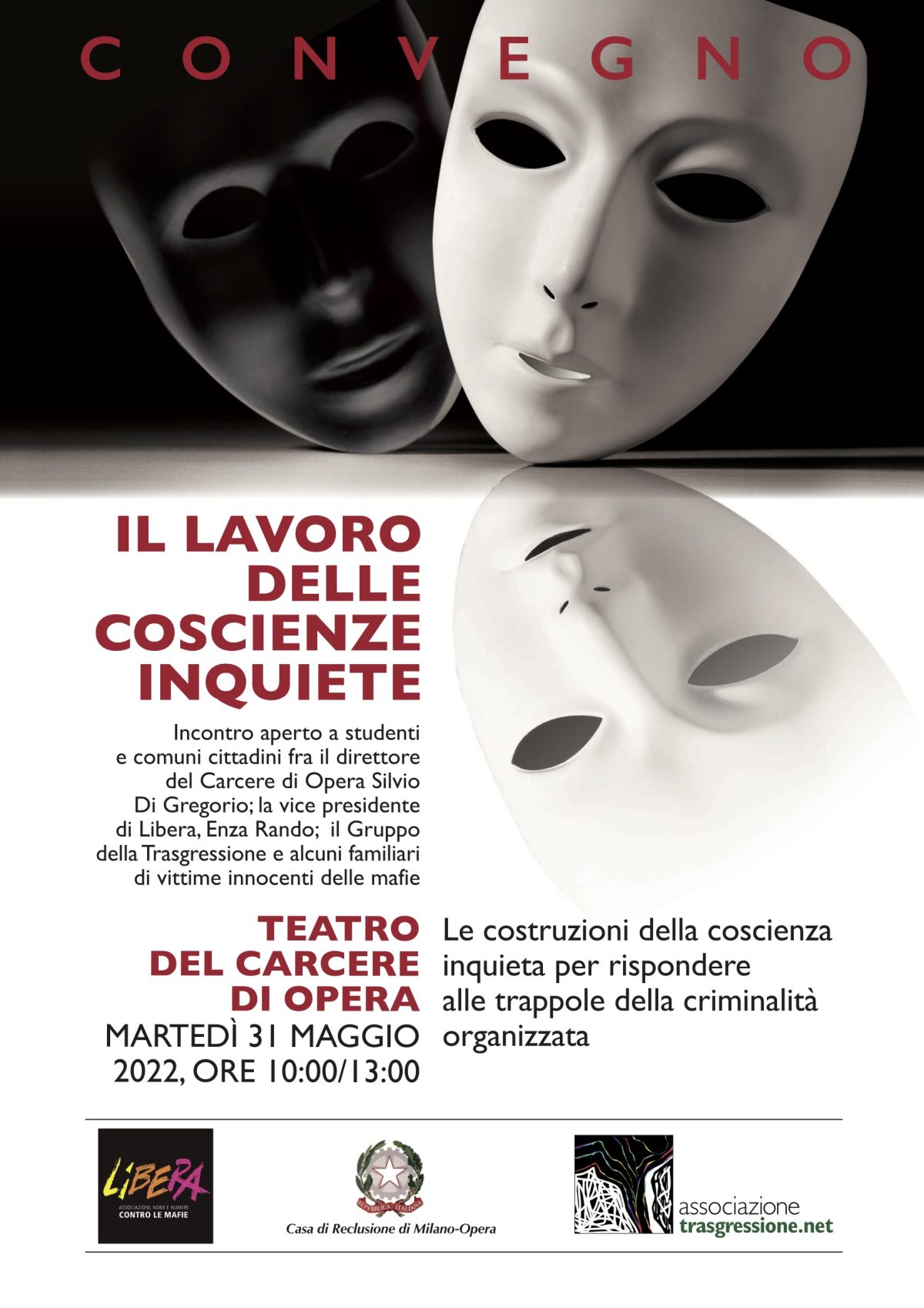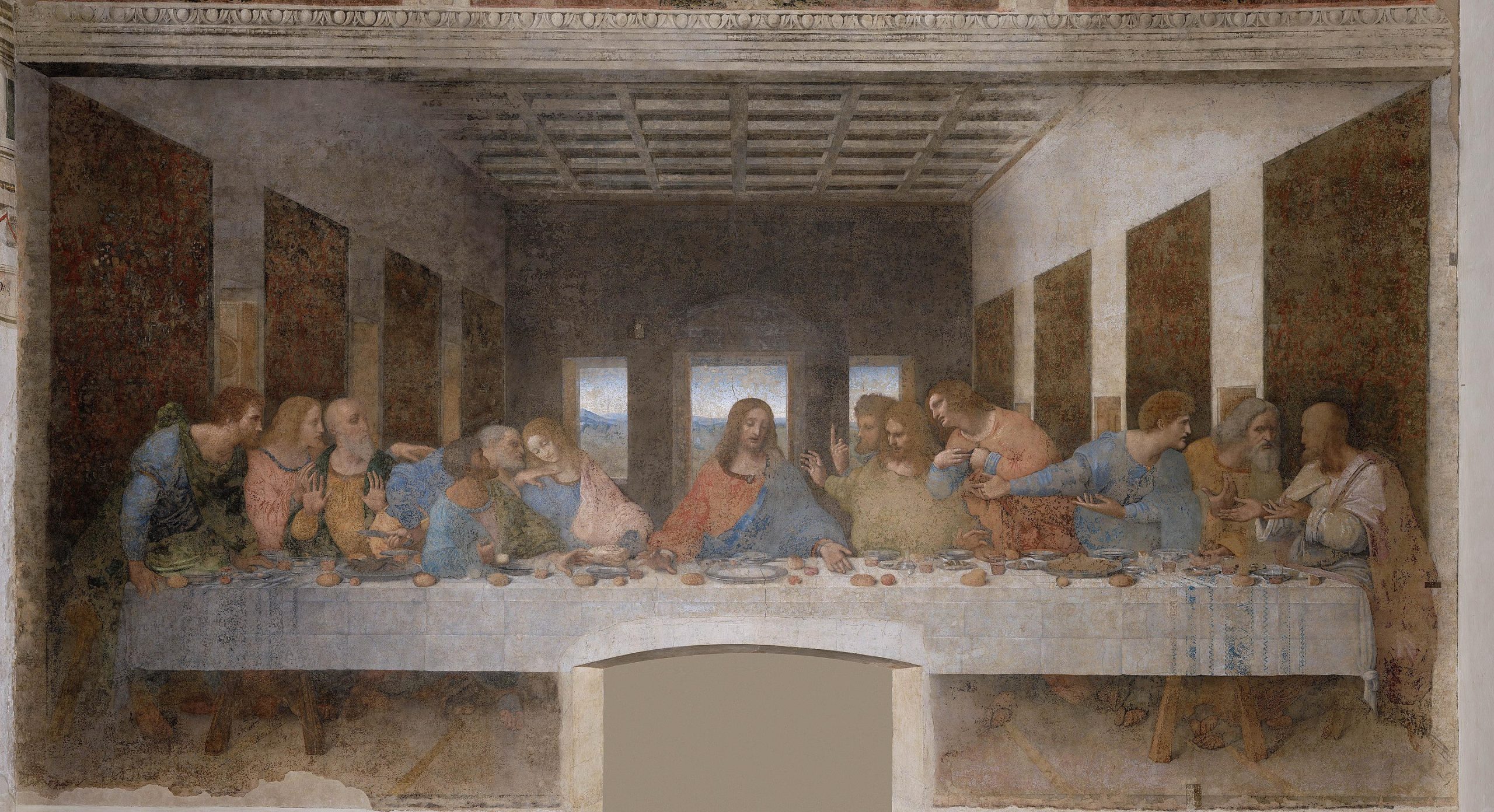Chi ha avuto occasione di partecipare a qualche riunione del gruppo della Trasgressione (Trasgressione.net), sa che ho deciso, un anno fa, di entrare in carcere ad Opera per essere più vicino ai detenuti, per dialogare non solo con coloro che avevano già raggiunto un livello di consapevolezza e ristoro della propria coscienza tale da godere di permessi e benefici, ma anche con coloro che per qualsivoglia motivo si trovano all’inizio del percorso ovvero nel mezzo del guado. Mi ero infatti detto che è più utile e stimolante mettere mani in pasta là dove c’è ancora materia da sbozzare, piuttosto che contribuire ad affinare contorni ormai definiti di un qualcosa che già presenta un solido aspetto.
Non a caso la scelta è stata quella di entrare in un mattino di luglio, quando la caldazza spingeva i più verso freschi lidi o valli di montagna, in quel periodo dell’anno in cui le vacanze si impongono a governare tempi, destinazioni e occupazioni del mondo esterno, mentre quello interno, segregato e abbandonato, può solo continuare a spuntare i giorni a venire e dotarsi di pazienza, maledicendo le ferie che impongono pause, smorzano gli entusiasmi, minano fragili abbozzi di certezze precarie, restringono ulteriormente gli spazi di libertà. Sentivo l’urgenza della continuità di una presenza vitale, che non merita e non vuole pause. E soprattutto non ne ha bisogno.
Mettere mano al magma è come lavorare con la sabbia sulla battigia, giocando con quello spirito infantile che mi è stato dapprima sottratto, e che più tardi mi sono negato, per apparire maturo e responsabile. Occorre farlo con mente sgombra dai pregiudizi che ti attendono al varco dietro ogni svolta, e con la voglia di costruire assieme attraverso il dialogo, a partire da riflessioni, sentimenti, umane emozioni tra loro anche molto diverse: è in quella prossimità che si matura assieme.
L’emancipazione dal trauma e dal dolore è un’esperienza a due facce, che vale per il colpevole e per la vittima, poiché entrambi ne hanno bisogno. Non c’è nulla da insegnare, occorre solo attivare il racconto e l’ascolto, e nutrirsi a vicenda di tutto il potenziale disponibile dei compagni di viaggio. Non c’è nulla da travasare, né lezione da esporre, né nozione da infondere, c’è solo da scoprire dentro ognuno di noi il meglio che vi alberga. Non mancano consigli, ma il percorso lo si fa scegliendo di volta in volta il cammino, spesso su erba fresca, alta, rigogliosa, che serra la vista, raramente seguendo un sentiero già abbozzato. Non ci sono stelle a guidare il cammino, né punti di riferimento prestabiliti. E non a caso il tavolo del gruppo somiglia molto a un letto ostetrico, ad una sala parto, dove la maieutica regna sovrana.
Ognuno, esterno o interno che sia, porta spontaneamente il suo fardello, il suo contributo, le sue riflessioni, le esperienze di un’esistenza più o meno sofferta, la malattia del suo vivere, le cure dolorose, le cicatrici, le lunghe convalescenze, le rinascite, le gioie: uno scambio, un’esperienza di dialogo e di riconoscimento reciproco. Riflessioni che vengono esposte, osservate, accolte, accarezzate, curate, e abbracciate. E’ una pratica di mutuo ascolto, sostegno, soccorso, accoglienza e conforto. Attenzione senza pregiudizi.
Paradossalmente è qui che il mio dolore si è svolto pienamente, le mie fragilità si sono esposte, le sofferenze comuni si sono confrontate, le scelte fortunate, quelle possibili e quelle azzardate e salvifiche sono state esposte, in una narrazione tra pari, sempre più consapevoli delle proprie fortune e miserie, delle loro cause, delle responsabilità di ognuno e il ruolo di ogni cosa nel destino personale. La mia vita profondamente, irrimediabilmente segnata dall’evento, come la vostra, quella di ciascuno di voi; le vostre vite parimenti distrutte, le vostre famiglie, i vostri figli e a cascata nipoti, amici, parenti. Dolori diversi, per natura e per fonte, benché simili per conseguenze e per intensità. Con la consapevolezza, lentamente acquisita, che le nostre sofferenze si sommano, non si elidono, che la vostra sofferenza non mi porta sollievo, nulla sottrae al mio dolore. Che è il cambiamento osservato e praticato a soddisfare l’umano bisogno di dare un senso ed un valore al dolore comune. Che si corre il rischio di tradire la propria carne, o di esserne accusati, e che queste accuse arriveranno comunque e dovranno trovarci forti, saldi e sereni nella nostra pratica onesta e consapevole.
L’emancipazione è reciproca, speculare: anche le vittime hanno bisogno di essere aiutate ad emanciparsi dal male subito, dalla logica della vendetta, a liberarsi dal risentimento e dal rancore, mentre l’autore di reato si fa responsabile non solo di qualcosa, o per qualcosa ad appagare l’ordinaria logica retributiva, ma anche verso qualcuno e qualcosa, allargando progressivamente il suo orizzonte di responsabilità consapevole verso i figli, la famiglia, il nucleo sociale, la vittima ed i suoi familiari, la società nell’orizzonte più ampio. Emergendo dal carapace egoistico ed autoreferenziale che raffigura il vissuto di molti autori di reato, sordi da sempre all’ascolto del dolore inferto.
Ed è quella stessa società che vorrebbe attribuirci una funzione penale, chiedendoci di giudicare della congruità delle pene irrogate, di valutare l’autenticità del percorso di rieducazione dei colpevoli o la possibilità di accordare loro il perdono comunitario. Richieste sbagliate ed improprie: compiti che non competono ai familiari di vittime, poiché attengono alla funzione pubblica, e che si vorrebbe delegare per non assumersene la responsabilità, velando la delega di falsa sensibilità ed ipocrita rispetto, riproponendo nei fatti la visione arcaica e privata della giustizia, tutta interna al vissuto vittimario, viscerale, succube del cortocircuito rancore-odio-vendetta. All’opposto, se un qualcosa è giusto da un punto di vista civico, se è previsto dalle leggi, lo si faccia. Se non lo è, non lo si faccia, e non è che non lo si fa per non dispiacere ai familiari delle vittime. Della loro opinione o risentimento allo Stato non deve importare, deve esserne indipendente.
L’emancipazione della vittima, oltre a sottrarsi a queste ambiguità e tranelli, chiede di evadere dal ruolo vittimario, di liberarsi dello stigma da cui si è segnati, di rinunciare a vivere passivamente i benefici della condizione di vittima, tra cui l’innocenza oracolare o il credito perenne. Richiede di arrivare a cancellare il debito, che rimane comunque insoluto, purificando attivamente il ricordo della violenza subita, purgandolo del suo potenziale perennemente divisivo e distruttivo: liberare la memoria dal rancore, dalla zavorra di violenza vendicativa. Si tratta, spiccando il volo, di rinunciare spontaneamente al diritto al risarcimento ancestrale, che è l’unico modo per accostarsi al perdono in forma personale, per chi ci crede, lo pratica o lo cerca, oppure per partecipare alla più corale riparazione della lacerazione del tessuto sociale, pur conservando traccia e memoria degli eventi. Volgere il capo in avanti, al futuro, a nuova vita, poiché noi familiari di vittime siamo vivi, rimanendo pur sempre ancorati al ricordo del passato, ed additando percorsi felici di virtù da sperimentare consapevolmente, e gioiose, sorridenti imitazioni responsabili, anziché indossando plumbee corazze, zavorre soffocanti e paralizzanti. Consci di essere stati condannati ad un ergastolo emotivo da cui è difficile evadere, consapevoli che viviamo innocenti una vita molto diversa da quella che avevamo sognato, serenamente certi che nessuno si salva da solo.
Per i responsabili, emanciparsi significa dapprima lambire, poi lentamente apprendere ed infine condividere rimorso e pentimento, ri-scoprendo sentimenti ignoti, allontanati, rimossi, acquisendo coscienza e responsabilità sempre negate o rifiutate, prendendo cognizione del proprio e dell’altrui dolore, causato con scellerate pratiche di abuso, arroganti e narcisistiche. E lentamente, progressivamente, accettare nuove regole, riconoscere autorità finora ripudiate, contribuire ad emancipare il carcere dall’interno, con responsabilità e coscienza. Il cambiamento non è un compito, né uno scopo del gruppo, è semplicemente un’opportunità offerta; non si pensa di dover cambiare nessuno, ma esso è per certo il più fecondo risultato osservabile, consapevoli che non tutto dipende dal nostro lavorare assieme, e che probabilmente saranno altri a raccogliere il frutto del nostro lavoro di oggi.
In passato ho immaginato orgogliosamente di voler essere, con la mia presenza, macigno sulle vostre coscienze, ma ho anche sinceramente temuto di soffocarle. Meglio essere levatrice umile e gentile, felice osservatore della vita che nasce, del cuore che si risveglia, della coscienza che ritorna alla luce. Non si sa mai che cosa sarà, ma si sa che è vita, che può, fiorendo, dare il meglio di sé.
In molti mi avete detto che essere qui con voi è un insperato segno di vicinanza, di riconoscimento e di rispetto della vostra dignità. Quello che voglio dirvi con queste righe è che io stesso sono stato profondamente cambiato dal dialogo con voi, dal vostro lavoro ho appreso molto, mi avete arricchito più di quanto pensassi e mi aspettassi, pur senza confondere i ruoli e dimenticare: questa prossimità non vuole né guidare né assolvere, né plagiare né redimere. La salvazione è personale, la ricchezza del rapporto pure. Dal lavoro comune ognuno colga il meglio che può dare, traendolo da dentro di sé.
Giustizia Riparativa, dare senso al dolore delle vittime
Paolo Setti Carraro