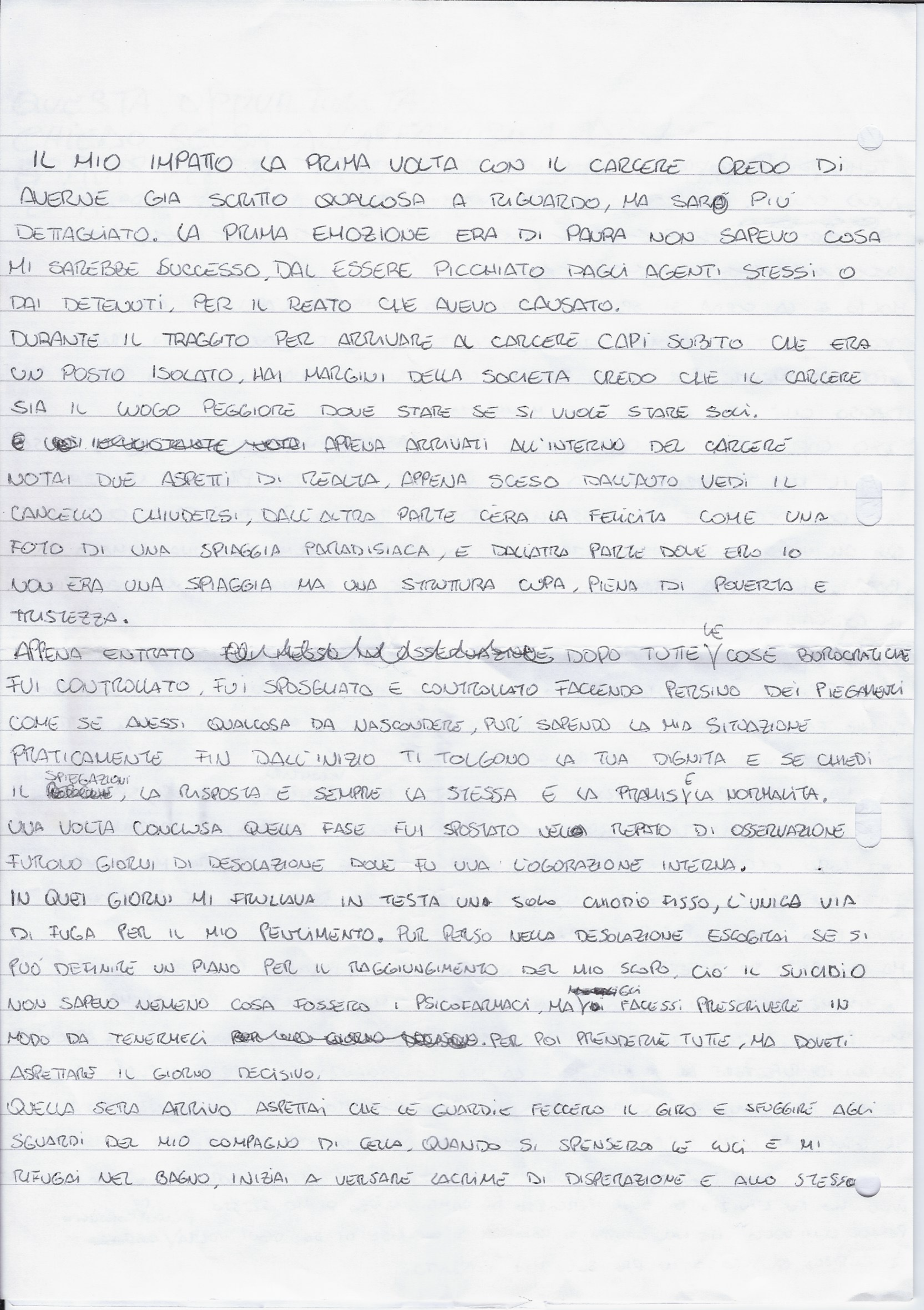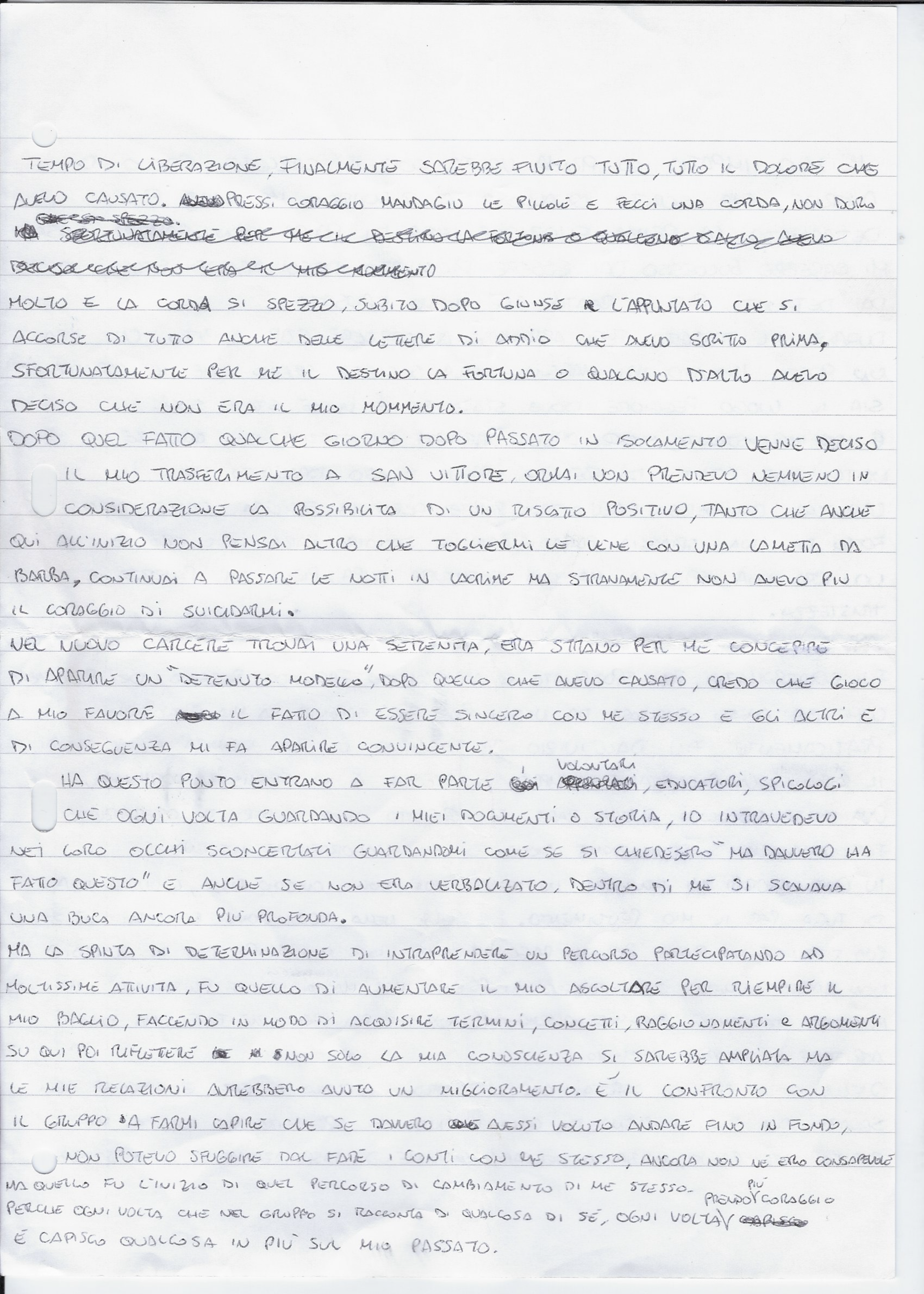Durante uno dei miei primi incontri del Gruppo della Trasgressione a Opera, il professor Aparo disse una frase che mi colpì e che, da un po’ di tempo a questa parte, utilizzo anche io per spiegare di cosa si parla al Gruppo: “A questo tavolo non si parla di carcere.” Ricordo che rimasi abbastanza stupita, ero dentro ad un carcere con una decina di detenuti: di cosa potevamo parlare se non di carcere?
In quel periodo però per parlare dovevo emettere fatture e non volendo pesare eccessivamente sull’associazione, decisi che avrei trovato da sola la risposta alla domanda semplicemente ascoltando. Da due anni a questa parte ho ascoltato storie di genitori e storie di figli, storie di terre del Sud e di povertà, storie di potere, di arroganza e di seduzione, storie di morte e di vittime. Ma anche storie di rivalsa e di cambiamento, storie di responsabilità, di conoscenza e di sensi di colpa, storie d’amore, di vita e di libertà.
Storie di libertà, in un carcere. Com’è possibile?
Sempre più spesso mi capitava di sentire i detenuti dire che il Gruppo permetteva di sentirsi liberi e non capivo: come può una persona sentirsi libera quando è in una condizione di restrizione? Quando deve seguire regole in ogni momento e ogni cosa che gli capita dipende da altri?
La parola libertà io me la sono tatuata sulla pelle a ventidue anni, quando ero in Erasmus a Vilnius. Lì mi sono sentita per la prima volta totalmente libera, lontana da tutto ciò che conoscevo e completamente indipendente. Le prime settimane la libertà per me era poter tornare alle cinque del mattino senza dover rendere conto a nessuno, mangiare patatine sul letto guardando un film senza dover pensare a mettere in ordine le mie cose e poter bere alcolici senza dovermi preoccupare di nasconderlo a mia madre. Con il passare del tempo però la libertà è diventata anche l’essere in grado di fare una lavatrice senza tingere tutto di rosso, l’imparare una nuova lingua da zero ed essere in grado di sostenere gli esami, riuscire ad arrivare a fine mese con un budget tirato e, soprattutto, provare piacere nel chiamare la mia famiglia e condividere con loro la mia crescita. La libertà aveva assunto per me un nuovo significato: ero responsabile di me stessa e quindi, ero libera.
Sono stati gli incontri al Gruppo ad aiutarmi a mettere a fuoco la relazione tra responsabilità e libertà. I diversi confronti permettono infatti una crescita della coscienza che, nella maggior parte dei casi, culmina nella consapevolezza della propria responsabilità, individuale e collettiva. Assumersi la responsabilità delle proprie azioni comporta il raggiungimento di una libertà che non è più la libertà fisica di muoversi e fare quello che più ci piace, diventa libertà di conoscere e accettare noi stessi, con i nostri limiti, pregi, difetti e responsabilità, e imparare a conviverci.
Assumersi le proprie responsabilità non coincide solamente con il confessare i propri reati e il male che è stato fatto: è più un viaggio in profondità, che va a zappare, zolla dopo zolla, sulle convinzioni e sull’identità di una persona. È difficile per me, quindi fatico a immaginare come possa essere per un detenuto scavare nella sua identità e lavorare con il conflitto che si crea inevitabilmente quando si rielabora il proprio passato.
Tuttavia, è proprio il conflitto che spinge le persone a farsi delle domande e permette al detenuto di comprende che, forse, la libertà non l’ha mai conosciuta perché, nella vita, è sempre stato schiavo. Schiavo del potere, dell’arroganza, della facilità e della violenza. Schiavo del brivido e dell’adrenalina che porta una rapina compiuta. Schiavo della Mafia, che gli ha impedito di vedere e riconoscersi nell’altro. Perché la Mafia, alla fine, rende tutti schiavi, che tu sia una vittima, un parente, un soldato o un boss. La consapevolezza della schiavitù instilla il dubbio: ma sono stati i reati che ho commesso a rendermi schiavo oppure è stata l’incapacità di riconoscere l’altro?
La difficoltà è proprio nel riconoscere di essere stati schiavi, perché a ognuno di noi piace pensare di avere il controllo della propria vita e di essere consapevoli delle nostre scelte, di essere indistruttibili. Ma per essere liberi bisogna conoscersi e scoprirsi, portando a galla fragilità che nessuno vuole vedere.
Mi piace pensare al Gruppo come a una squadra di palombari che ci aiuta a portare a galla i nostri pensieri più profondi e, attraverso il confronto, li sostiene fino a che non imparano a galleggiare da soli, permettendoci di riconoscerci in essi.
E adesso capisco perché al tavolo non si parla di carcere: il carcere ti permette di restare immobile e in silenzio per anni, per essere liberi bisogna imparare a crescere e a rispondere di sé.
Percorsi della devianza – Reparto LA CHIAMATA